Le mine tedesche esplosero il 24 luglio 1944 danneggiando case e strade del centro di Empoli, ma anche dei dintorno. Alcune immagini sono state scattate in luoghi imprecisati, invitando i lettori a scriverci per fornire elementi utili a indivuarli.
IN AMARITUDINE, Capitolo 2° – di Tommaso Mazzoni
Chi non sa ricordare il passato
è condannato a ripeterlo(*).
George Santayana, filosofo, scrittore
e poeta spagnolo (1863-1952).
L’illusione è la gramigna più tenace
della coscienza collettiva: la storia insegna,
ma non ha scolari(*).
Antonio Gramsci (1891-1937).
di Tommaso Mazzoni
L’argomento di questo capitolo che ho definito “secondo” è affine al precedente, ma premetto subito che hanno analogie, nei loro rispettivi dolorosi e seri contenuti, tanto da considerarli idonei ad essere purtroppo, per la loro reale, inaudita drammaticità, ancor più fatti conoscere.
Dopo che mi ero interessato, rispettivamente, di Saffo Morelli e di Mauro Betti, con una certa emozione vengo a parlare, o meglio, a lasciar parlare ora un mio caro e vecchio amico.
Il perché lo capirete se vorrete leggere, come mi auguro, i capoversi che seguiranno, non tanto quelli scritti da me, ma direi soprattutto quelli che riguardano il personaggio che mi onoro di presentare a chi segue i miei scritti – incluso e naturalmente a maggior ragione – a chi mi ha seguito anche sul filo di questi particolari, inquietanti argomenti.
Già, anche allora Siro Terreni ed io eravamo amici, compagni alla Scuola di musica di Empoli, quando, poco più che imberbi, tutt’e due studiavamo teoria musicale e imparavamo a suonare il clarinetto.
Ci siamo ritrovati ora, attempati anziché no (è vero, di anni ne son davvero passati parecchi!), a frequentare le lezioni istituite e tenute a pro di coloro che dispongono di tempo libero (soprattutto anziani) allo scopo di consentirci di mantenere la mente un po’ più allenata. Cosa assai ben fatta, certo, e, sebbene le lezioni abbiano un costo (oggi ci fanno pagare anche l’aria che si respira), ben volentieri frequento córsi del genere, dove, se non per altro, mi sono trovato nella fortunata coincidenza di rivedere e anche di frequentare l’amico Siro, oggi con le qualità aggiunte – questo va pure detto – di pittore, di scrittore e di chissà cos’altro.
Terreni, infatti, ha tenuto diverse mostre e alquanto recentemente ha pubblicato un suo libro, intitolato «Un Nonno Racconta».
Ma riprenderò un po’ più avanti quest’ultimo argomento, giusto perché ne vale la pena e perché questo mio dire è perfettamente in tema con tali contenuti.
Ebbene, a Siro Terreni, oltre alle traversìe comuni a tutti noi mortali, è purtroppo toccato di dover subire la mostruosa deportazione operata dalle truppe tedesche nel corso della seconda guerra mondiale.
Non molto tempo fa, a conoscenza di questi suoi precedenti, presi l’occasione per consegnare, a questo amico ritrovato, un piccolo plico dattiloscritto contenente i due miei capitoli (che penso abbiate già letto) dai titoli “Arbeit macht frei” e “In Amaritudine”. I temi di quest’ultimi sono affini, dato che Saffo Morelli e Mauro Betti, secondo le loro peculiari, tristi esperienze, hanno raccontato le proprie rispettive, inusuali, disumane vicende.
Ebbene, con l’occasione dell’incontro con Siro Terreni a una delle lezioni di cui dicevo, il medesimo mi ha consegnato a sua volta un plico. Ed è precisamente quello relativo al contenuto che riporterò, quale altrettanto originale ed appropriata integrazione al mio capitolo che già portava il titolo “In Amaritudine”: è un argomento affine ai due precedenti, intendevo dire, ma ovviamente rievocante situazioni diverse fra loro.
Comincio dalla lettera che Siro mi consegnò mercoledì pomeriggio del 10 dicembre 2008, e che qui di seguito ricopio così come sta. Volentieri la sottopongo alla vostra lettura, soprattutto allo scopo che possiate maggiormente rendervi conto della personalità del suo autore:
«Caro amico Tommaso.
Attraverso il tuo appassionato lavoro di ricerca mi informi di due testimonianze: quella di Mauro Betti e di Morelli Saffo del quale serbo un bel ricordo legato alla mia adolescenza: col volo dell’aquilone e il giro della trottola sotto il porticato del convento dei frati a S. Maria(1), alternati al responsabile compito del lavoro nella fabbrica per aiutare la famiglia, dopo la guerra, lui superstite dai campi di sterminio, io da quelli di concentramento in simbiosi d’idee e del doveroso compito di trasmettere ai giovani la memoria(2) attraverso le esperienze fatte nei lager nazisti.
Il tuo compito di paziente ricerca si colloca in questo percorso divulgativo utilizzando le testimonianze nei racconti dei superstiti, fedele nella trascrizione, legate al tragico periodo storico.
Un sincero apprezzamento per il tuo lavoro.
L’amico… anche dei percorsi culturali. Siro Terreni».
Come dicevo, Siro mi ha consegnato i documenti manoscritti, che sto trascrivendo qui naturalmente dopo aver ottenuto il suo consenso, senza modifiche e senza nulla escludere.
Comincio intanto con quello che Terreni ha intitolato:
«Un viaggio… il ritorno dopo 2 anni.
8 settembre 1943 – 8 settembre 1945».
«Il viaggio dall’Italia verso la Germania ebbe inizio da Tortona (AL)(3) dove ero a svolgere il servizio di leva presso il 38° Regg. Fanteria. Avevo 19 anni, anni vissuti nella campagna Toscana che attorniava il mio paese, un paese legato a vecchie usanze ed abitudini in cui il contadino era legato alla terra da un contratto di mezzadria e nel borgo si svolgevano attività artigiane: la vita era legata ad una quotidianità in cui il tempo scorreva in modo sereno e felice, e persino la miseria era vissuta in modo dignitoso e con grande rispetto per le cose e la natura. Quindi quel viaggio si svolse nel dubbio e sentivo che qualcosa di tragico turbava la mia mente, provocato dalle condizioni pessime che si svolgevano in quel vagone, dove avevo preso posto insieme a 70 compagni di sventura, chiuso dall’esterno e vigilato da guardie armate tedesche. Un finestrino rettangolare crociato di filo di ferro spinato dava luce al sinistro luogo al quale ci si alternava per respirare aria più ossigenata in quanto il vagone, col passare del tempo, era diventato lurido e puzzolente dato che i bisogni corporali si svolgevano in un angusto spazio; per lo smaltimento avevamo fatto un foro nel pavimento.
Come vissi quei 5-6 giorni! tormentati dal dubbio, dall’incertezza della meta, bagliori di speranza venivano dalla vicinanza degli amici. I ricordi facevano sentire che ogni ora trascorsa in modo estenuante mi allontanava dalla famiglia e dal mio paese.
Ricordo su dei foglietti scrivevo, oltre al nome, la località di residenza dei genitori e la notizia della mia buona salute e l’augurio di rivederci presto, che venivano raccolti e comunicati ai genitori, che così potevano seguire il mio percorso durante il quale atti di solidarietà venivano dalle persone fornendoci cibo, notizie e qualcuno persino a liberare la chiusura che avrebbe permesso la fuga, che fu scelta da 2 compagni che, dal treno in corsa nel buio della notte, si gettarono nel vuoto pieno di incognite e di pericoli.
Il lungo viaggio in Italia fu segnato dall’ultima tappa a Udine, che continuò tra le montagne rocciose delle Dolomiti che segnavano il confine tra l’Italia e la terra straniera; e quello scenario maestoso era un sipario che si chiudeva alla mia patria.
In quelle ore vissi momenti di grande tensione emotiva e un grande turbamento nei miei pensieri. E i dubbi si accentuarono.
La mia prima tappa fu nel grande campo di smistamento di Luchenwald, dove migliaia di prigionieri girovagavano in cerca di notizie e di qualcosa da mangiare, in quanto quello concesso dal comando tedesco era una misera scodella di sbrodaglia e le notti erano segnate da risvegli inquietanti; lì subii la prima spersonalizzazione togliendomi il nome e sostituendolo con un numero, 119214, che mi accompagnò nei 600 giorni della mia prigionia.
Guardie tedesche armate vigilavano, non permettendo che si formassero gruppi, e per sedare manifestazioni di protesta contro le leggi del regime nazista usavano la frusta e minacciavano con le armi.
Infine la meta: Berlino, dove ero costretto insieme ad altri prigionieri a svolgere lavori forzati in condizioni devastanti il fisico e il morale fino all’alienazione; molti si condussero alla pazzia e al suicidio; il mio fisico era sceso al peso di 38 kg.
Potrei continuare a raccontare episodi sconvolgenti, rimando, a chi interessa, la lettura del mio diario di prigionia.
Siro Terreni».
Procedo ora a trascrivere, qui di seguito, il suo diario di prigionia, per far considerare, a chi avrà la bontà di proseguire nella lettura di queste pagine, quali e quante traversìe abbia dovuto affrontare il mio amico, “reo” del solo fatto, ovviamente senza volerlo, di essersi trovato in una situazione che ha però determinato, purtroppo, quanto ha dovuto incolpevolmente subìre. Potrete mettere così ancora più a fuoco cosa significhi la scelleratezza delle guerre, di ogni guerra, spessissimo anche a danno di bambini, di donne, di vecchi…
Traggo i capoversi che seguiranno, quindi, dalla copia autografa di detto diario, che ha voluto offrirmi e che personalmente trascriverò, come ogni sua altra parola, integralmente e fedelmente.
Se doveste stancarvi nel córso della lettura, potete lèggere il contenuto di questi scritti anche a più riprese, ma si finisce, lo premetto, col ritrovarsi in ogni caso angosciati ed inquieti.
«Dal Diario di Prigionia di Siro Terreni
a Tommaso Mazzoni»
«Il 30 agosto 1943 lasciai il mio paese, Empoli, per raggiungere, a Tortona (AL)(3), il 38° Reggimento Fanteria assegnatomi dal distretto militare di Pistoia per assolvere il dovere di leva, e con i quattro amici paesani le ore di libera uscita serale; per evitare gli incontri con gli ufficiali e godersi in libertà quelle poche ore disponibili, ci recavamo presso il torrente Scrivia. Fu proprio lì che arrivò la notizia dell’armistizio, un avvenimento che ci colse di sorpresa e ci mise nell’imbarazzo, accentuato dall’incertezza del comando del Reggimento che consigliava alla calma; infine l’ordine di non opporre alcuna resistenza ai tedeschi, i quali in principio erano titubanti ed esitavano ad apparire, ma, avuta la certezza della nostra passività all’azione, prendevano il sopravvento incominciando a sparare contro le finestre mandando in frantumi i vetri delle camerate; poi scariche di mitra, sempre più frequenti. Infine con la loro presenza spavalda e minacciosa, pronunciavano parole incomprensibili, accompagnate con un’espressione di rabbia come di cani mastini ringhiosi. E questo continuò per circa 7 giorni, tenuti nel piazzale della caserma Passalacqua sotto controllo 24 ore su 24 con sporadici spari di mitra fino al giorno della partenza per ignota destinazione, non lasciando intravedere quello che era nei loro propositi. Questo lo capii solo superato Udine e confermato quando, varcato il confine da Tarvisio, la maestosità delle montagne Alpine sembravano far barriera per un viaggio senza ritorno.
Intanto la lunga tradotta con i suoi 80 vagoni proseguiva con lentezza estenuante, col suo carico umano profondamente provato dai disagi, dalla stanchezza e dalle disumane condizioni igieniche: il vagone nel quale avevo preso posto con altri 64 era diventato un abitacolo invivibile, lurido e puzzolente; fu che ci concessero un po’ d’aria sotto numerosa sorveglianza. Durante il viaggio 2 compagni del mio vagone tentarono la fuga, ma alla libertà le chiuse la porta la morte, mentre altri, approfittando delle notti di chiaro di luna, si gettarono dal treno in corsa.
Dopo giorni e giorni di viaggio con lunghe soste, alternandoci al piccolo finestrino del vagone per respirare aria più ossigenata, guardavo il paesaggio circostante che mi scorreva davanti; ciò mi infondeva malinconia, facendomi sentire la nostalgia della mia Toscana. Infine l’arrivo a Luchenwald: un grande campo di smistamento occupato da migliaia di prigionieri di varie nazionalità: Francesi, Polacchi, Cechi, ecc. Cosparso di grandi tendopoli ove trascorsi notti insonni mentre di giorno, spinto dai primi morsi della fame, vagabondavo per l’esteso campo in cerca di cibo in cambio di cose personali. Ricordo del campo l’alta recinzione di filo spinato, le torrette ove vigilavano le sentinelle tedesche e una marcia umana che girava per il campo alla ricerca vana di notizie e di cibo, e quella lunga, interminabile colonna di gente dimessa ad aspettare il turno per una ciotola di zuppa; e, alla sera, la spettacolare visione dei bagliori di fuoco dei bombardamenti mentre i riflettori mobili illuminavano il campo creando una visione apocalittica. Non mi rendevo conto ancora di ciò che mi aspettava e così era per i quattro amici paesani con i quali dividevo tutto.
Si arriva così alla fine di ottobre ’43 e dopo un’intera giornata trascorsa per la disinfezione e per l’assegnazione della matricola: Stan Lager 3° A N° 119214.
Verso sera, senza preavviso e dopo un frettoloso conteggio, fu decisa la partenza per la nuova destinazione: Berlino, che raggiunsi verso le ore 24 insieme ad altri 50. Fortuna volle che scoprii, tra le traversine del vagone ove viaggiavo, qualche patata che divisi con l’unico amico paesano, e dopo un lungo percorso a piedi, con brevi soste, giunsi a destinazione; venuto in possesso di un pagliericcio, mi ci gettai sprofondando sull’istante nel sonno, con frequenti risvegli inquietanti. Al mattino mi fu data una sbrodaglia che bevvi tutta d’un fiato.
Quel cielo plumbeo, uniforme, quell’aria fredda e umida mi fecero ricordare e desiderare i cieli sereni e l’aria profumata della mia Toscana, e la sentii lontana, tanto lontana che una lacrima la sentii scivolare lungo la guancia. E man mano che i giorni passavano, tutto assumeva una dimensione distaccata da quelle cose infinitamente lontane; in compenso si stabiliva fra me e i 25 compagni della camerata un saldo rapporto d’intesa, di rispetto, di spontanea solidarietà, dettate dalle condizioni di bisogno; e non era certo la Chiesa ad aiutarci con i suoi frequenti interventi incitanti ad una paziente sottomissione, alla rinuncia, alla rassegnazione.
Ogni giorno un soldato tedesco ci accompagnava e ci sorvegliava sul lavoro; il vitto a mezzogiorno non era garantito, anzi spesso negato e si aspettava la sera la solita misera sbrodaglia.
Dopo poche settimane il campo subì un bombardamento americano che lo distrusse parzialmente. Il suo ripristino avvenne a tempo record sotto la frusta, la fame le ingiurie il freddo, e dopo qualche giorno un nuovo bombardamento lo distrusse completamente invece di colpire una fabbrica di armi; costretto a prendere le poche cose rimaste, con una temperatura invernale ed una pioggia insistente, camminai l’intera notte e parte del giorno successivo fino a raggiungere, stremato, il campo 190. Da lì si raggiungeva, con 1 ora e ½ di treno, la fabbrica, che produceva parti meccaniche di aerei e carri armati a fianco di civili tedeschi, i quali, per condizionamento del sistema dovevano evitare un rapporto confidenziale con noi.
Il lavoro si protraeva oltre le 9 ore al giorno e richiedeva molta attenzione e concentrazione, con un vantaggio: una zuppa calda a mezzogiorno, un etto di pane con salame o margarina e una volta la settimana sei sigarette, che davo in cambio per una cartolina da scrivere a casa, ma nella quale dovevo dire che stavo bene e che ero contento, pena di essere eliminata dalla censura tedesca. Alla sera, 2 ore di lavoro volontario in cucina per una manciata di bucce di patate, e prima di coricarmi confidavo al mio diario le mie amarezze, le umilianti azioni provocate dagli aguzzini tedeschi, ma anche i miei desideri e le mie speranze.
Una sera fui chiamato dal comandante del campo, un uomo tarchiato dall’aspetto severo e dall’espressione accigliata, il quale mi rivolgeva domande incomprensibili alle quali non potevo dare risposta mandandolo su tutte le furie: ciò riguardava il mio diario, trovato in un’accurata ispezione alla baracca, e dopo aver borbottato qualche parola al soldato, il quale mi ordinò di seguirlo, con una spinta fui scaraventato in un luogo buio: era una stanza d’isolamento e di punizione nella quale trascorsi 3 giorni senza razione di viveri, dopodiché fui condotto al tribunale militare ove fui condannato (?).
Era la fine di novembre 1944, una giornata fredda e umida, e la strada da farsi, a piedi, fu di 4 ore, con la scorta di un giovane soldato tedesco che mi portò in un vastissimo campo isolato nella campagna: era la prigione, e me ne resi conto dalla numerosa sorveglianza e dal ferro spinato a forma di croce ad ogni piccolo finestrino al di là del quale s’intravedeva un ambiente lugubre e insalubre delle celle.
Mi fu tolto vario vestiario e rimasi con la camicia e i pantaloni. Il misero corredo fu completato da un paio di enormi di zoccoli di legno, che dovetti calzare per tutto il tempo di permanenza nel campo; il freddo era tremendo, 10 gradi sotto zero, i giorni monotoni e interminabili li trascorrevamo stretti l’un l’altro con gli altri tre occupanti la cella, conversando a bassissima voce, pena l’esser puniti con un nerbo che feriva a sangue le carni.
Dalla cella vicina ci divideva una parete fatta di rozze tavole di legno, ed un francese ci narrava le sofferenze di quel luogo; spesso lo udivo piangere.
Ogni mattina sveglia alle ore 4; appena giorno venivamo mandati fuori per svolgere la consueta marcia quotidiana punitiva, che consisteva nel trascinarci dietro i pesanti zoccoli di circa 1 kg e mezzo l’uno attorno alle aiole del giardino, in quel periodo coperte di neve, l’uno dietro l’altro con le mani legate dietro, la testa china. Ciò doveva durare dalle 2 alle 3 ore con brevi soste, secondo l’idea che era nella “zucca” del comandante, che al di là di una vetrata, nella stanza riscaldata, spiava il nostro comportamento: quante volte per la cosa più banale, magari per la caduta per mancanza di forze, quella neve si è macchiata di sangue!
La sera del 2 dicembre 1944 suonò l’allarme, le guardie si erano recate nel rifugio, si udivano le bombe sganciate dagli aerei americani, che esplodevano sempre più vicino per l’esistenza, seppi dopo, di una colonna di soldati tedeschi che transitava nelle vicinanze; finché una bomba sganciata sopra di noi fece scricchiolare sinistramente l’intera baracca: per la paura si creò tra noi un baccano infernale. Alla fine i tedeschi, come impazziti, si scagliarono furibondi contro di noi colpendoci con qualsiasi cosa che gli capitava a portata di mano, in un silenzio tombale. Mi ero rassegnato alla sorte che si delineava, senza speranza. Cosa volevi sperare da quella gente la quale i lamenti di dolore scatenavano gli istinti e stimolavano la derisione più sfacciata.
Infine mi fu annunciato il trasferimento… anche questa volta ce l’avevo fatta! Prima di partire chiesi di salutare gli amici di cella. In quell’attimo che li guardai, sui loro volti erano evidenti i segni di una tremenda sofferenza, di una profonda umiliante rassegnazione. Abbracciai con lo sguardo quel luogo di morte e a fianco del tedesco camminavo sotto la pioggia, gettandomi di tanto in tanto a terra per potermi dissetare con l’acqua delle pozzanghere. Il soldato mi guardava e rideva.
Il nuovo campo ove ero destinato era composto da 5 baracche vecchie e sporche, con ogni sorta d’insetti: era la compagnia di disciplina. Nella stanza vi erano varie brande a castello di 2 piani, sprovvista di sgabelli e di luce, proveniente, di notte, di fuori, dai fari mobili e filtrando dalle piccole finestre, ed era occupata da 36 compagni prigionieri me compreso.
Ogni mattina mi recavo al lavoro che consisteva, quasi sempre, nel trasporto di materiali per la riparazione delle case danneggiate dai bombardamenti. L’acqua per dissetarsi era disponibile in appositi contenitori; per il mangiare qualche carota lessata insieme a qualche rapa ed una tazza di tè. Al ritorno, come una ritualità, la consueta marcia che consisteva nel trasportar sulla schiena, fermato da cinghie, un sacchetto di sabbia del peso di circa 13-15 kg., e sotto a quel peso, al comando, dovevo gettarmi a terra, rialzarmi, e questo senza un intervallo, per circa ¾ d’ora, dopodiché le solite 10 frustate sul dorso nudo, che si moltiplicavano per una o due volte, per un gesto mal interpretato od un lamento di dolore. A completare l’operazione, quasi sempre, il suono delle sirene costringeva a recarsi nel misero rifugio. In piedi, osservavo chi era seduto, chi sdraiato, chi malediva, chi pregava, chi bestemmiava e pensavo che da un momento all’altro una bomba, cadendo sopra di noi, ci seppellisse tutti.
Il mio fisico era ridotto al peso di 38 kg.
Dal medico italiano del campo ci veniva consigliato, nelle ore libere, per non sprecare energie, di stare distesi in branda, rilassati, senza pensare né parlare, creando intorno a noi un vuoto assoluto. La mia condizione morale aveva dei cedimenti per la situazione di alienazioni con un recupero straordinario. La rigida disciplina, il vitto ridotto ad una nullità, con lunghi periodi di digiuno, le crudeltà disumane inflittemi dai tedeschi, accentuata dalla loro condizione, dopo le orgiastiche riunioni con le puttane, inebriati dall’alcol, ci costringevano a uscire nel piazzale, svestiti e derisi di fronte alle loro donne.
Per la condizione di frustrazione e di carenze nutritive si manifestavano gravi forme di malattie polmonari ed esaurimenti nervosi che portavano molti al suicidio, la tubercolosi non curata portava inevitabilmente alla morte, le cui vittime venivano avvolte in luridi lenzuoli e sotterrate a fior di terra. Questa sorte toccò ad un amico di camerata chiamato il Romano. Sfinito dalla tisi, fu sepolto che era ancora vivo. Ricordo ancora il suo sguardo supplichevole, il suo flebile respiro rantoloso; fu udito il mio pianto dai tedeschi e la ripetuta maledizione a loro rivolta che mi crearono una costante tensione di paura.
Di questi e altri episodi è tessuta la vita di quei mesi: la ricerca di cibo era diventata una costante condizione ossessiva, che mi faceva avventurare nelle situazioni più rischiose e pericolose che rasentano l’incredibile, da stare nei giorni di festa vicino ai reticolati a elemosinare dai passanti qualcosa da mangiare, o stare per ore a scrutare oltre i reticolati perché l’erba affiorasse e frugare nella terra estirpando le radici e cibarsene, e quando preso dalla furia della ricerca persino sotto i bombardamenti che mi davano l’occasione di cambiare le scarpe logore con un paio usate ma buone, e qualche indumento più decente, due volte per 2 giorni rimasi sepolto sotto le macerie di un palazzo finché provvidenzialmente non arrivarono le ruspe a salvarmi. E con quanta avidità mangiai le carni saporose di quel cavallo bruciato per strada dall’incendio provocato dal bombardamento, fino alla fuga messa in atto insieme all’amico Gusso di Caorle (VE) nascosti per giorni nei posti più impervii e imprevisti, sotto i ponti, nelle case vuotate dai bombardamenti finché la fame non ci fece, come al lupo, uscir di tana. Dettato dal bisogno, s’impararono vari espedienti nell’arte di arrangiarsi per calmare un po’ la fame, quella fame che mi aveva portato a mangiare di tutto, persino cose in stato di putrefazione trovate nelle pattumiere.
Mi preme ricordare l’aiuto ricevuto dalla famiglia Petersen, stufa della guerra, che ci tenne nascosti vicino alla casa, con grande rischio per la vita di tutti qualora i tedeschi ci avessero scoperto. Se sono tornato vivo molto lo devo a loro.
Le notizie dell’avvicinarsi del fronte Russo davano alimento alle mie speranze, anche se molti pericoli insidiavano lo svolgimento delle cose: nei tedeschi più fanatici e agguerriti era diffusa l’idea di non cedere alla resa. Li vedevo correre all’impazzata, sparando senza un preciso bersaglio. Mi sono trovato fra essi, ultimi relitti di un esercito disfatto, ormai vinto, sul fronte con dall’altra parte i Russi, che incalzavano, tra morti, disperazione, feriti che imploravano soccorso, solo, tremendamente solo!, che assistevo a scene di un’immane tragedia. Nell’imbarazzo mi domandavo più volte: che fare? Altri prigionieri che incontravo nel cammino si facevano la solita domanda che esigeva una decisa risposta: fu di stare con i tedeschi per aspettare di essere liberati. E i Russi arrivarono decisi a farla finita, e in questo scenario in cui si concludevano le sorti di una guerra, tra i bagliori di fuoco e il rumore delle armi e dei mezzi cingolati, esplose la gioia della ritrovata libertà; ed era un accorrere da tutte le parti di prigionieri Russi, Polacchi, Cechi, Italiani, Francesi, ecc. ecc. a salutare con abbracci, strette di mano i liberatori. Era il 23 aprile 1945.
Quella gioia che provai la capirà solo chi è stato coinvolto a lottare per la vita, lontano dalla propria patria, dai propri cari, sperduto come in un labirinto infernale, e se la morte non ti toglie da vivere, si rivive con quella gioia che non vorrei riprovare…
Siro Terreni».
Seguono, da parte del caro Siro, alcune riflessioni, che ha intitolato “Considerazioni”. Le faccio qui seguire nella loro integrità:
«Le colpe non siano date al popolo della Germania ma al sistema nazista che lo coinvolse nei fatti, un sistema che gli uomini devono condannare perché certe cose non si ripetano più».
«Sul nazifascismo: non rimettere il giudizio alla casualità e alla fatalità ma ai fatti realmente accaduti, analizzati in senso critico».
«Finche l’uomo fa la guerra, segno che non sa far uso della ragione».
«Gli episodi si possono raccontare, ma le paure, le ansie, il dolore, le umiliazioni scavano solchi profondi nell’animo a livello anche inconscio e che ti accompagnano per tutta la vita».
Terreni conclude il suo dire accorato con la nota che segue:
«Dagli episodi del diario e da un’esemplare lezione della storia si fa evidente il giudizio: che la violenza e l’istintività prolificano là dove l’uomo vuol dominare sull’altro, e se i suoi interessi non si sviluppano verso ideali di altruismo per un’umana convivenza è soggetto al condizionamento e perde la caratteristica di essere civile, socialmente organizzato e libero.
Da un interesse comune nasce il valore dell’aiuto reciproco, la reciproca stima ed il rispetto reciproco».
Siro Terreni, è nato il 18 settembre 1924 e abita(5) a Vinci.
Concludo così anch’io questo capitolo dedicato a una persona, Siro Terreni, che ha sofferto e che, come traspare dal suo accorato racconto, porta con sé i segni psicologici di una non certo lieve sofferenza.
Un giovane non ancora ventenne, nel fiore della vita, viene sradicato e proiettato in un mondo ostile che non poteva nemmeno immaginare…
Proprio nulla di male, aveva fatto ad alcuno, ed ha subìto e subìto poi. Uomini fatti come lui e come noi, però trasformati in mostri dalla follia nazista, hanno torturato e vilipeso loro simili, sovente perfino godendo di quei loro misfatti.
A questo proposito, confrontate anche, nelle prime pagine del primo articolo “In Amaritudine”, quanto ho riportato circa le testimonianze di Mauro Betti…
Tutto concorda nel dover giudicare infami (ma questo è un termine che uso solo io) i comportamenti di chi si è macchiato di tali e così tante malvagità: sia Saffo Morelli, sia Mauro Betti, sia Siro Terreni, però, osserverete, nelle loro esposizioni non sono scesi a esclamazioni offensive nei riguardi di coloro che li hanno torturati e vilipesi; così come hanno riconosciuto e ricordato le buone azioni di quei cittadini della Germania che si sono prestati a sfamarli e, per quanto possibile, anche ad assisterli con grande rischio per tutti, soccorritori ed aiutàti. Anzi, mi sembrerebbe di essere nel giusto aggiungendo che è proprio per il comportamento di certe persone dabbene – ossia normali cittadini della medesima Germania – che alcuni deportati, internati nei campi nazisti, sono riusciti a sopravvivere e a poter riabbracciare i loro cari.
Anche le famiglie dei deportati non devono certo aver goduto, nel sapere e pensare i loro congiunti così lontani da casa e in luoghi sconosciuti!
Però, se vi figuraste, o amici che leggete ciò che mi è stato possibile riportare, di queste vicende grazie ai sopravvissuti! Se vi immaginaste cosa s’agita dentro di me quando prendo contezza, attraverso siffatte testimonianze, di cosa, e poi di quanto hanno sofferto queste persone!
Cose accadute – teniamolo pure presente – a molti, moltissimi loro compagni di sventura, molti dei quali non sono potuti, oltretutto, nemmeno rientrare nella loro e nostra Patria: non tutti hanno potuto resistere a quelle crudeltà.
Si sono comportate bene le tre persone che vi ho presentato da queste pagine, però, ossia questi tre eroi della vita, nel continuare ad avere fiducia nel prossimo, anche e soprattutto compiendo azioni altruistiche, perché dettate dalla propria coscienza e da una così costosa esperienza.
E fanno realmente tutto il possibile(4), in virtù della loro sensibilità e delle loro ponderate riflessioni, per mettere in guardia le future generazioni. Operano, instancabili(5) nel loro impegno di trasmettere i fatti realmente accaduti, nel tentativo, che mi auguro quanto più possibile fruttuoso, di scongiurare ogni ricomparsa delle premesse e i conseguenti, sempre possibili, futuri rischi per le nostre esistenze e la nostra stessa civiltà.
Empoli (FI), mercoledì 24 dicembre 2008 23h55’.
TOMMASO MAZZONI – QUASI UN DIARIO.
PROPRIETÀ RISERVATA. Pubblicato per gentile concessione dell’autore.
Note e Riferimenti:
(*) – (Acquisizioni dell’a. successive alla stesura del presente capitolo).
(1) – Frati a S. Maria – Il Convento dei Frati Minori di San Francesco in Santa Maria a Ripa (del sec. XV-XVI, ma l’edificio è attestato fin dal XII secolo). Tale Convento si trovava – e si trova – nella frazione di Santa Maria a Ripa, ad ovest del territorio comunale di Empoli; oggi, però, fa parte integrante della città.
(2) – Trasmettere ai giovani la memoria – Siro Terreni, spostandosi quasi sempre a cavallo della sua bicicletta, ha raggiunto tantissime scuole dove ha raccontato, a numerosissimi scolari e studenti, i suoi trascorsi di uomo che ha sofferto per le peripezie subite. Ha saputo tuttavia porgere una materia così scabrosa intervallando le sue narrazioni con il riferire usi e costumi della sua (e mia) epoca, al fine di non gravare il suo dire. Tuttavia ha raccontato quanto ha sentito dentro di sé come un dovere, trasmettendo alle nuove generazioni quanto gli è ahimè capitato. Certamente nella speranza, cosa che nutriamo tutti noi uomini dabbene, di poter influenzare favorevolmente le generazioni future e avere qualche possibilità in più di scongiurare il ripetersi di tali sciagure.
Teniamo presente che quello che è avvenuto una volta potrebbe ripetersi, seppure in forme dissimili, ma con le medesime finalità perverse. Anch’io non ho mai trascurato occasione per ricordare tutto ciò.
Nel libro di Siro Terreni, intitolato appunto – come più sopra avevo già citato – «Un Nonno Racconta», fra l’altro vi sono riportati diversi disegni dei ragazzi delle scuole insieme a tante affettuose e toccanti letterine. Va detto anche che, in molti casi, le letterine e i disegni sono supportati, talora con enfasi, dai rispettivi insegnanti, che lo ringraziano esprimendo affetto e riconoscenza per il suo encomiabile, non comune impegno.
(3) – Tortona (AL) – In provincia di Alessandria, appunto: si trova precisamente a est di Torino, sempre in Piemonte, e a nord di Genova, in Liguria.
(4) – Fanno tutto il possibile – Ora mi viene di pensare, in particolare, a Saffo Morelli, il quale, non molto dopo che c’eravamo incontrati, ossia il 22 aprile 1999, ci ha invece purtroppo lasciati: è deceduto, infatti, il 7 marzo del 2000.
Non era trascorso nemmeno un anno, da quando avemmo quel colloquio di cui ho riferito.
(5) – Questa nota, densa di tristezza, devo aggiungerla per la morte improvvisa dell’amico e collega Siro Terreni.
Come avevo accennato agli inizi del presente capitolo, con Siro sono stato amico in gioventù… e purtroppo il giorno 12 Dicembre di questo freddo Dicembre 2013 il mio amico è morto.
Ai Suoi funerali, ad accompagnarlo eravamo in tanti. Il minimo che potevamo fare per una così degna persona.
Come pure in tanti gli volevamo bene e, ne sono certo, continueremo a volerglielo. Come si fa a non voler bene a Siro? Lo ricorderemo per sempre, come sono da ricordare le persone rette e colme di tanta buona volontà come Lui.
Auguriamoci che il Suo esempio venga seguìto da molti: ciò che ha fatto, non risparmiandosi mai, lo lascia ben sperare, anche se i tempi non sono purtroppo dei migliori neppure per il rispetto della Memoria.
Con il mio pensiero affettuoso per il mio amico Siro, porgo le condoglianze alla Famiglia, estese a tutti quelli che Gli hanno voluto bene.
Comments (1)
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.




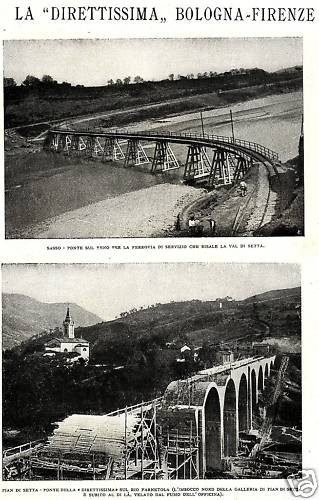
Gran bel racconto! Ho potuto leggere solo la prima parte ma mi ha avviato parecchio e non vedo l’ora di poter proseguire