Fondo Caponi, Empoli, Volume 2 pagina 2: Presentazione della Mostra delle attività empolesi svoltatasi nel Giugno…
Notizie Istoriche della Terra di Empoli scritte dal Canonico Luigi Lazzeri
Anno 1774.
Pel nuovo regolamento dato dal suddetto principe alle comunità della Toscana, con di lui mutuproprio de’ 23 maggio di quest’anno furono uniti alla nostra Comunità, i due Comuni limitrofi, che avanti formavano la lega empolese, quello cioè di Pontorme, e l’altro di Monterappoli. Secondo la della nuova riforma i rappresentanti la Comunità di Empoli sono in numero di selle, il primo dei quali dicesi Gonfaloniere e 22 sono i capo-popoli, che hanno voto nel Consiglio generale soltanto, rappresentando questi i 22 popoli, che da quest’epoca in poi compongono la predetta Comunità, l’ordine de’ quali secondo il citato regolamento è l’appresso:
Popoli dell’antico Comune d’Empoli
1. S. Andrea d’Empoli.
2. S. Angiolo a Empoli Vecchio.
3. S. Maria a Ripa.
4. S. Iacopo ad Avane.
5. S. Pietro a Riottoli
6. S. Martino a Vitiana.
7. S. Cristina a Pagnana.
8. S. Michele a Pianezzoli.
9. S. Giusto a Petroio o Pretoio.
10. S. Simone e Giuda a Corniola.
11. S. Leonardo n Cerbaiola.
Popoli del Comune della Lega di Pontorme
1. S. Michele in Pontorme.
2. S. Martino a Pontorme.
3. S. Maria a Cortenuova.
4. S. Donato in val di Botte.
5. S. Maria Oltrorme.
6. S. Pio a Ponzano (63) .
Popoli del Comune della Lega di Monterappoli
1. S. Giovanni a Monterappoli.
2. S. Lorenzo a Monterappoli.
3. S. Bartolommeo a Brusciana.
4. S. Stefano alla Bastia.
5. S. Iacopo a Stigliano (64).
Anno 1784.
Il Granduca Pietro Leopoldo avendo emanata una legge per cui si proibiva l’inumazione dei cadaveri nelle chiese, e si ordinava l’ erezione de’cimiteri a sterro fuori de’ luoghi murati; i rappresentanti la nostra Comunità in esecuzione de’ sovrani comandi decretarono l’erezione di un cimitero pubblico per la popolazione di questa Terra. Fu fabbricato dirimpetto al convento dei cappuccini, cioè distante da Empoli circa due terzi di miglio per la parte di mezzogiorno; alla di cui spesa, che fu di L. 11000, concorsero in compagnia di S. Andrea, e quella della SS. Annunziata già ora soppresse, questo spedale di S. Gìuseppe, ed il nostro Monte Pio. Fu benedetto solennemente coll’intervento del clero della Collegiata dal proposto Benedetto Falconcini il dì 31 maggio di quest’anno suddetto assieme coll’oratorio eretto in onore del martire S. Donnino; e nel muro esterno di detto cimitero presso il cancello fu posta I’appresso iscrizione composta da ser Ranieri Mazzantini cancelliere in questo tempo della nostra Comunità:
RENOVATA. JUSSU.
PETRI. LEOPOLDI.
P. R. H. ET. B.
A. D. A.
M. E. D.
XII. TABULARUM. LEGE.
HOMINEM. MORTUUM. IN. URBE. NE. SEPELITO.
NEVE. URITO.
EMPULENSIS. MUNICIPII. DECURIONES.
DIVI. JOSEPHI. NOSOCOMII.
PII. PIGNORUM. FORI.
AC.
SODALITATUM.
DIVI. ANDREÆ.
ET.
MAGNÆ. VIRGINIS. DEI. PARENTIS. RENUNCIATÆ.
AERE. CONLATO.
DOMUM. MORTALITATIS.
CINERIBUS. ATQUE. OSSIBUS. REVICTURIS.
HEIC. FACIUNDAM. DECREVERE.
EDICLAMQUE. DIVO. DOMNINO.
JAMDIU. IN. VICINO. PAGO. EXCULTO (65).
INTUS. SUFFECTAM.
AD. LARES. PIORUM. MANIUM.
SACRIS. ABOLENDAS.
DICARI. VOLUERE.
CURANTIBUS. TRIUMVIRIS.
I. U. D. NICOLAO. RICCIO.
SEBASTIANO. VANGHETTO.
AUGUSTINO. CECCHIO.
ANNO R. S. MDCCLXXXIV (66)
La riferita memoria dell’erezione di questo pubblico cimitero rilevasi dal campione beneficiale del nostro Capitolo a c. l93.
Anno 1791.
Per render grazie all’Altissimo del fausto avvenimento al trono di Toscana del Granduca Ferdinando III figlio di Pietro Leopoldo stato nostro sovrano ed ora giù Imperatore di Germania nel dì 12 e 13 giugno di quest’anno fu posta nella pubblica venerazione sull’altar maggiore della nostra Collegiata l’lmmagine del SS. Crocifisso detto delle grazie: e nel dì 14 in luogo della medesima, fu esposto su detto altare l’Eucaristico Sacramento, avanti al quale nella stessa sera fu cantato in musica l’ inno ambrosiano, come pure in musica furono cantate le tre messe e i vespri in questo triduo. Le compagnie laicali del nostro Piviere ed alcune ancora fuor di Piviere si portarono a venerare la sacra Immagine con offerte di donativi: l’apparato della chiesa fu assai maestoso, e similmente quello della piazza. Il concorso del popolo fu grandissimo: a cui in tali giorni fu dato l’ onesto divertimento di due corse di cavalli, d’una macchina di fuochi d’artifizio e di una vaga illuminazione della piazza, e delle strade del paese nelle sere dei giorni sopraindicati (67) .
Anno 1799.
Dopo la celebre rivoluzione di Parigi seguìta l’anno 1789 che farà epoca nella storia universale, i Francesi desiderosi di dilatare il loro dominio, o piuttosto l’irreligione, il libertinaggio, il dispotismo nel 1796 voltarono le armi a’ danni d’ltalia, col pretesto di liberarla dai suoi tiranni (68), e combattendo vittoriosamente, e predicando a’ popoli la libertà, ed eguaglianza, detronizzarono a poco a poco i legittimi sovrani, che dominavano in essa, e vi stabilirono varie repubbliche schiave a catena della regicida repubblica di Parigi. Anco alla nostra Toscana toccò finalmente tal sorte infelice. Entrati i Francesi in Firenze il dì 25 marzo 1799 cacciaron via il Granduca Ferdinando III e vi eressero la democratica repubblica, piantandovi al solito l’albero detto della libertà. Non mancarono partitanti di questa nascente repubblica; e sebbene qui in Empoli pochi si trovassero aderenti alla medesima, pure anche qui si dovettero vedere estesi gli effetti della di lei influenza, mentre nel dì 2 aprile dell’anno citato di sopra, fu eretto nella piazza l’albero famoso che fu un cipresso tagliato con prepotenza dall’orto del convento dei cappuccini. Il cipresso fu creduto segno lugubre, e perciò poco dopo in suo luogo vi fu sostituito un ramo di alloro. Si andavano intanto facendo forti premure ai rappresentanti questa Comunità, perché si decretasse l’ erezione di un altro albero più decoroso determinandone un dato giorno per questa cerimonia repubblicana. Si dové cedere alle istanze, e si mosse perciò in ordine uno stile ben lungo dipinto a tre colori, con bandiere, fascie da erigersi nella piazza. Il Magistrato Comunitativo voleva, che stesse in piedi la colonna di pietra posta in detta piazza, di cui sul capitello si vedeva un leone sostenente con una zampa l’arme medicea detto volgarmente Marzocco, nella di cui base si leggeva inciso – A. D. MDCXV. oct. idus juli – (69). Ma ad onta di tal determinazione si pretese non solo atterrare la colonna, come seguì il dì 20 aprile, che anzi si voller di più togliere le armi gentilizie degli antichi potestà nella facciata del tribunale; il chiavistello dei Samminiatesi ivi collocato fino dall’anno 1397 e molte altre armi situate nelle facciate delle case de’paesani. E fatta erigere nel luogo del marzocco una nuova base, nelle di cui quattro facciate stava inciso – libertà – legge – eguaglianza – anno VII. repubblicano – (di Francia), e su di cui doveasi collocare l’albero precitato: stavano gli autori di tutto ciò in grande espettativa del giorno 13 maggio(secondo di Pentecoste) a tal funzione determinato. Si rendeva ogni giorno più insopportabile il giogo di questa immaginaria libertà, ed eguaglianza repubblicana, e se ne desiderava la liberazione. Già l’Imperatore Francesco era in guerra colla nazion francese, e si sapeva, che ne riportava vittorie. Avvenne pertanto, che la sera del dì 4 maggio si spargesse voce in Empoli, che l’armata imperiale aveva incominciato a entrare in Toscana, e che si avvicinava a Firenze: anzi di più, che in detta città vi erano entrati i Commissari Tedeschi per intimare ai Francesi l’ evacuazione; e cose simili si raccontavano con motivi all’apparenza non equivoci di probabilità. Tanto bastò per mettere in grande orgasmo il popolo empolese, e perché i ragazzi corressero alla piazza a prendere quel ramo d’alloro simbolo della libertà, e lo strascinassero per le vie del paese, o poi lo bruciassero, gridandosi frattanto da molti del popolo – viva l’Imperatore – In questo tempo proveniente da Firenze passava di qui un Ussaro francese con dispacci per Livorno. Questi veduto il fermento del popolo, voltando addietro in silenzio, tornò a Firenze a darne parte al Generale. A far credere maggiormente le buone nuove al popolo si aggiunse intanto, che nella sera suddetta si veddero grandi fuochi in tutte le colline, e ne’poggi più lontani, che scorger si possano dal nostro piano. Non vi volle altro perché fosse creduta indubitata la voce della prossimità de’ Tedeschi; e che perciò molti entrati nel medesimo entusiasmo corressero a prender quello stile che dovea inalzarsi nel dì 13 del mese e colle bandiere, e fascie tutto bruciarono in mezzo di piazza, e demolirono in un momento quella base di pietra, che lo doveva sostenere. Quindi inalberata una croce a piè di cui posero l’arme del Granduca Ferdinando III gridando – viva Gesù, viva Maria, viva l’Imperatore e Ferdinando – la portarono a processione per le strade in mezzo a quantità di torcetti. Nella susseguente mattina, che fu domenica, si fece in Empoli gran quantità di popolo e più nel giorno tutti con coccarde imperiali, esternando il giubbilo, e l’allegrezza per le nuove credute. Furon collocati di nuovo a’soliti posti l’armi del Granduca, e il noto chiavistello. Vi furono suoni di banda, applausi, evviva e nuova processione colla croce suddetta. Si erano preparati gran fuochi per la sera, e già incominciavan questi ad ardere, quando giunse la notizia che una truppa di Francesi a cavallo veniva alla volta d’Empoli. Il gaudio si converti presto in mestizia, e ognuno pensava a salvarsi, o i forestieri a fuggire (70) . Molti paesani fatti arditi si armarono volendo andare incontro alla truppa per resistergli. Si diede nelle campane ai martello, che in questa notte furon sonate più volte, e si adunarono sul campaccio circa mille persone tutte armate diversamente. l signori Michele Del Bianco nostro proposto, e Dottor Luigi Busoni si provarono a sedare il tumulto, ma non vi riuscirono del tutto. La truppa composta di sessanta individui a cavallo sentito l’ammutinamento si fermò a Pontormo. I precitati Signori si presentarono al comandante della truppa Pinarr pel buon successo della di lui venuta a Empoli. Pinarr promise tutto bene, volendo soltanto la tranquillità del popolo. l tumultuanti del campaccio invece di acquetarsi fecero nuovamente suonare a martello; il che uditosi dalla vicina truppa, il comandante spedì a Firenze per dei rinforzi; tanto più che un cotal Pontormese, sulla fiducia di giovare al nostro paese, gli rappresentò che gli armati d’ Empoli erano circa tremila. Nella mattina susseguente 6 di maggio di buonora i prelodati soggetti, con altre persone autorevoli del paese si presentarono nuovamente all’ufiziale predetto esponendogli che tutto il paese era in calma, e che perciò poteva entrarvi sicuro. L’ufizial comandante rispose, che non poteva senza che fosse prima giunto l’ufizial maggiore, che aspettava da Firenze. Le dette persone vi tornaron più tardi per parlare al detto ufiziale Espert comandante della piazza di Firenze. Questi dopo un solenne rimprovero fatto loro per non aver saputo sedare il popolo tumultuante giunse a Empoli con circa 120 uomini d’infanteria, ed altrettanti di cavalleria, seco avendo un cannone con miccia accesa. Il comandante Espert mandò subito un editto con cui intimava: 1.° Che in termine di 24 ore si erigesse nuovamente l’albero della libertà 2.° Si depositassero tutte le armi da fuoco e da taglio; 3.° Si prendesse da tutti la coccarda francese. 4.° Si accusassero i capi della sollevazione. Questi furono gastigati colla carcere, finché non venne un general perdono, il che successe sulla fine di maggio. L’armi furono consegnate con riportarne ciascuno una ricevuta per la loro ricuperazione a suo tempo; ma non passarono molti giorni, che altre furono spezzate, altre rubate, altre prese da’medesimi Francesi. Espert dopo tre giorni partì colla truppa, avendo lasciati alcuni ussari di guarnigione e un tal Ponte in qualità di comandante della piazza d’Empoli e Samminiato. Fu fatta in seguito in tutta la nostra Comunità, una requisizione de’ migliori cavalli, con promessa di pagamento; ma questo non venne mai. Si ordinò, che tutti dall’età de’ 18 a 25 anni si ascrivessero alla truppa nazionale; ma non se ne trovarono, che circa otto, o dieci, che prendessero l’armi in difesa della Nazione (71). Il 12 giugno seguì nella sala della nostra comunità il famoso civil funerale fatto per ordine del Governo ai due Commissari francesi mandati dal direttorio di Parigi per trattare di pace coll’Imperatore di Germania, che furono con assassinio uccisi a Rastadt pretendendosi, benché falsamente, che ciò seguisse per ordine del suddetto Imperatore. La sala era parata di nero, e ornata con festoni di cipresso, che pendevano dagli archi della facciata del palazzo di detta comunità. Nella medesima sala vi era una specie di pulpito parato a lutto con vari motti, alcuni de’ quali esprimevano la desiderata vendetta contro gli assassini. Fra gli altri poi ve n’era uno, che diceva: – SE LA REPUBBLICA NON VINCE, IL GENERE UMANO É PERDUTO. –
Il vicario posto in Empoli dai Francesi vi recitò un’orazione funebre, nella quale esagerò la crudeltà e la barbarie dei complici di quest’assassinio. Dopo di ciò ne seguirono alcuni suoni di strumenti a lutto. Dipoì il comandante Ponte montato in bigoncia giurò con queste espressioni: – Giuro odio eterno, vendetta eterna alla casa d’Austria complice dell’assassinio de’ Commissarì di Rastadt. – Si voleva poi obbligare a questo giuramento il primo rappresentante la nostra Comunità, ma avendo egli ricusato, fu deposto dalla carica. Fu invitato il popolo, che era presente a prestare un tal giuramento, contro la di cui volontà giurò un certo Musico napoletano, che qui si trovava, al quale si unì alzando una mano, qualcuno dei partitanti, restando intanto il rimanente del popolo inorridito sull’espressione del medesimo giuramento. Dopo di ciò fu sciolta l’adunanza. La botta data ai Francesi dagli Austro-Russi alla Trebbia, sulla fine di giugno di questo stesso anno 1799 costrinse i medesimi Francesi ad evacuare l’Italia, e perciò anche la nostra Toscana. In conseguenza di che il nostro comandante Ponte nella mattina del dì 5 luglio partì d’Empoli col vicario, e con quella guarnigione, che vi era. Fu tale, e tanta l’allegrezza comune in quest’ occasione, che si vedeva esternata sui volti di chicchessia; pure ammaestrato il popolo dal successo nel 5 maggio si stette in silenzio. Ma nel dì 6 luglio al comparire in Empoli d’una guardia palatina del Granduca, che veniva di Firenze con dispacci per questo tribunale di giustizia, il popolo non poté più contenersi dall’entusiasmo esternato coi soliti – evviva -. Si corse perciò da molti all’albero della libertà, che era stato piantato in piazza fino dal dì 6 dello scorso maggio, e si svelse fino dalle barbe; si ruppe il cancello che avea all’intorno; si lacerò la bandiera tricolore, e si ripresero nell’istess’ ora le coccarde imperiali e toscane. Dopo non molto furono di nuovo collocate ai suoi posti l’ armi granducali. Pel benefizio ricevuto della suddetta evacuazione dalla Toscana fu determinato farsene un ringraziamento all’Altissimo con esporre per tre giorni l’immagine di Maria SS. venerata nella nostra Collegiata sotto il titolo dell’lmmacolata Concezione. La beata vergine sensibile alle miserie, che erano per succedere all’Italia, mediante l’invasione delle suddette truppe oltramontane, aveva esternato verso di noi il suo patrocinio cioè prodigi avvenuti nella Capitale del mondo cristiano, in varie città dello stato pontificio, e ancor di Toscana. Era dunque dovere, che ottenutasene finalmente in quest’anno la liberazione per mezzo di Lei se ne rendessero a Dio le giuste grazie (72). Nei giorni pertanto 19 20 e 21 di luglio fu esposta la detta sacra imagine della Concezione all’altar maggiore della nostra Collegiata con maestoso apparato, e in ciascun de’ medesimi giorni fu cantata una messa – Pro gratiarum actione -; l’ultima delle quali fu celebrata pontificalmente da monsignore Gio. Batta. Maria Scipione di Roux de Bonneval vescovo di Senez nella Provenza, che abitava in Avane presso Empoli; perché espulso dalla sua cattedrale in tempo della persecuzione del clero di Francia. In questo triduo le compagnie, e i popoli tutti della nostra Comunità, cantando laudi a Maria SS. vennero con donativi a visitare la suddetta di lei sacra Imagine, dietro un invito grazioso fatto loro dal Brigadiere Giovacchino Scarlatti, che risedeva in questa Terra in qualità di maggiore della legione mobile d’Empoli e Samminiato composto di 1200 soldati urbani. Dopo il vespro del terzo giorno di questa festa fu portata la medesima sacra Imagine a processione per Empoli, a cui intervenne col nostro clero il suddetto vescovo, le quattro religioni, e molte compagnie del Piviere, con di più quella della pieve di Limite. Il concorso del popolo fu immenso essendo apparsa pienissima la piazza, terminata che fu la processione, in atto che sul cimitero della chiesa si diede al medesimo la benedizione.
Anno 1800.
Fino dal mese di giugno di quest’anno fra l’Imperatore, e la Repubblica francese vi era armistizio, in cui restava compresa anche la Toscana. In conseguenza di ciò si aspettava da tutti una pace generale, e tranquilla. Ma fu tutto all’opposto; onde per le nuove rotture fra le due potenze, le armate Francesi occuparono nuovamente la Toscana entrando in Firenze il 15 ottobre. Nel dì 17 passarono di qui marciando per Pisa e per Livorno circa quattromila soldati d’ infanteria e da questo tempo in poi e per molti e molti giorni, fu un continuo passo di dette truppe, per le quali la nostra Comunità era necessitata tenere in pronto grosse provvisioni di tutto il bisognevole. Fu mandato di nuovo l’editto pelle deposizione dell’armi; ma non ne furono consegnate che in piccol numero, e cattive. Fu ordinata un’altra volta la requisizione dei cavalli; ma la fresca memoria di quanto era successo nella prima, fece sì, che non venissero condotti alla nostra piazza che pochi cavallacci; onde come inservibili a quanto era d’uopo, furono tutti resi a’ loro padroni. Frattanto intesosi dal general Pino, che era a Siena, che s’avvicinavano l’armate imperiali, credé bene allontanarsi di lì e trasferirsi a Empoli colla sua divisione cisalpina, che era di circa 3500 uomini tra infanteria e cavalleria. Qui giunse il dì 17 dicembre, e vi si trattenne fino al 24 del medesimo. Questa truppa a cui in modo particolare poté adattarsi il detto di Virgilio – Nulla fides, pietasque viris, qui castra sequuntur – (Aeneid. lib. 2) perché composta per la massima parte della schiuma del partito repubblicano di molti luoghi, appena giunta in Empoli incominciò a danneggiare, e in Paese, e in campagna. La nostra Comunità dové pensare a tutto il bisognevole pel mantenimento della medesima (73). L’ufizialità era alloggiata al solito nelle case de’ proprietari più comodi, dei quali’ molti oltre al letto, lume e fuoco, doveron pensare del proprio anche al vitto. Furon demandate per detta truppa nell’istante dell’arrivo 1500 paia di scarpe, delle quali non fu possibile trovarne che un numero assai limitato: e poco prima di partire furono chiesti 500 cappelli di cui in fretta ne furono trovati solo 70 circa. L’altro generale che era colla precitata truppa dimandò una gratificazione di dugento zecchini, de’ quali ne furono pagati circa un terzo pell’impossibilità di trovar danaro: e ciò volle per non aver fatto alcuno ostaggio in Paese, ne averci posta veruna contribuzione. Fu chiesta finalmente altra somma di danaro per le spese del burò militare, e per evitare una sollevazione della truppa, se non avesse trovato in pronto i foraggi e le razioni al punto della partenza, che fu assai di buon’ora, e senza averla manifestata se non pochi momenti prima (74) .
Si trattava nuovamente la pace tra le due potenze belligeranti, ed era per conchiudersi in breve a Luneville onde le truppe repubblicane si credevan prossime per tornare a’ loro paesi. Per questo alloggiando in Empoli nel dì 11 del susseguente gennaio circa cento soldati francesi i più di cavalleria, chiesero alla Comunità una contribuzione, che per grazia dové loro sborsarsi nella somma di scudi 500 e passarsi di più le razioni doppie a tutta la detta soldatesca.
Anno 1801.
Regnavano in quest’anno nel vicinato d’Empoli moltissime malattie dette tifi nervosi divenute contagiose; e pericolose non poco. Anche in paese eran molti attaccati da tal malore e se ne temevano funeste conseguenze. Si vuole che il passo di alcune truppe infette da tal morbo fosse di detta influenza la cagione. Perciò fu proposto che si esponesse per tre giorni alla pubblica venerazione l’antica e devota imagine di S. Niccola da Tolentino, che si venera nella chiesa de’ PP. Agostiniani di questa Terra, per ottenerne da Dio la liberazione mercé l’intercessione dì detto santo. Ciò seguì ne’ giorni 12 13 e 14 giugno. Il clero della nostra Collegiata, e le fraterie di questo Piviere si portarono in corpo o visitare la detta sacra lmagine, e nell’ultimo giorno di detto triduo fu fatta per Empoli una processione colla Reliquia del medesimo santo, a cui intervennero le compagnie del luogo, e gran quantità di popolo. Grazie a Dio, ed all’intercessione del santo, il male andò in breve a cessare (75).
Anno 1804.
Nel decorso del mese di ottobre di quest’anno si sentirono sopra a quindici scosse di terremoto più e meno gagliarde, ma senza altro danno pel nostro Paese, che d’un generale spavento degli abitanti. Ad accrescere poi i timori fino da molti giorni ci era pervenuta sicura notizia, che in Livorno regnavano certe malattie dette fabbri gialle, per cui molti di quella Città passarono all’altra vita, causate dall’aver data pratica nel porto a una nave contro le regole di sanità. E sebbene in certa distanza da Livorno fosse stato tirato il cordone dalla milizia, acciocché il male non si propagasse entro Terra, e se ne producesse un contagio universale; pure per motivo di molti livornesi che avevano diloggiato dalla Città prima del cordone, e di più per motivo di trasporti già seguiti di varie mercanzie specialmente per Arno, e per altre cause ancora si poteva temere di conseguenze funeste. Per implorare adunque la liberazione dai detti mali fu determinato ricorrersi a Gesù Crocifisso venerato nella di lui immagine detta delle grazie, che si conserva nella nostra Collegiata. Due altri motivi si aggiunsero di ricorrere al Crocifisso Signore; e furono di chiedere la felicità del viaggio del Sommo Pontefice Pio VII che andava a Parigi a coronare l’lmperatore Napoleone e la prosperità dell’infante nostro Re Carlo Lodovico, unico rampollo del trono d’Etruria dopo la morte del Re Lodovico di lui genitore. Il dì 4 novembre di quest’anno suddetto si esegui la decretata funzione essendo giorno di domenica. La sacra Immagine fu posta all’altar maggiore con decente apparato della chiesa. Dopo il vespro fu portata a processione per Empoli e principalmente alle quattro porte del paese, ove fu data colla predetta immagine la santa benedizione. A tal processione intervennero col nostro Clero le quattro religioni, le compagnie della Terra ed alcune del piviere, con di più quella di Pianezzoli, e dietro il baldacchino il nostro Magistrato comunitativo. Soffiò in tutto questo giorno forte vento di tramontana e il tempo assai piovoso appena diede luogo a farsi la processione; pur non ostante la gente che vi concorse dopo il mezzogiorno fu innumerabile essendo stati precedentemente invitati dai due superiori ecclesiastico e secolare i popoli del piviere e del vicariato. Più che 500 furono i lumi portati in detta processione e assai copiose le offerte fatte tanto in cera che in danari. Dagli ultimi giorni di ottobre in poi non si sentirono più terremoti; e s’ ebbe altresì la consolante nuova che col terminare di novembre cessò in Livorno la precitata malattia.
Anno 1808.
Fino dal mese di decembre dell’anno 1807 la Toscana era divenuta per la terza volta soggetta al grande impero francese. Questo governo non contento d’aver mutate costumanze, sistemi, e leggi (76) volle di più por mano in mille affari ecclesiastici, de’ quali non si stà qui a ridire. Solo aggiungo, che per ciò, che riguarda la nostra patria, che in virtù del decreto dell’lmperator Napoleone firmato 24 marzo 1808 essendo restate soppresse in Toscana tutte le corporazioni religiose sì dell’uno, che dell’altro sesso, restò in conseguenza soppresso il nostro convento degli Agostiniani dopo il corso di anni 513 dalla sua fondazione, e quello dei Carmelitani di Corniola presso Empoli ove era esistito per anni 239. Le monache Benedettine del paese ottennero una sospensione, vivendo intanto con l’emolumento delle pensioni loro assegnate, giacché il Governo si era impossessato di tutti i beni stabili e mobili della Toscana. Siccome poi a norma del decreto dell’amministratore generale della medesima Toscana Dauchy firmato in Firenze 29 aprile di quest’anno 1808, e pubblicato per l’esecuzione del precitato decreto imperiale il dì 29 maggio, venivano provvisoriamente eccettuate dalla soppressione le corporazioni religiose di mendicanti, e quelle fra l’altre che avean per oggetto la pubblica istruzione; così fu esente dalla stessa soppressione il convento de’ minori osservanti di S. Maria a Ripa, quello de’ nostri cappuccini, e il monastero delle domenicane posto in Empoli, attesa l’educazione e l’istruzione delle fanciulle che vi si tiene fino dal tempo in cui fu dichiarato conservatorio.
Anno 1810.
Il decreto dell’Imperator Napoleone de’ 13 settembre ordinava, che restassero in Toscana definitivamente, e interamente soppressi tutti gli ordini monastici, e congregazioni religiose d’uomini e di donne ad eccezione soltanto di certi istituti, che han per oggetto l’assistenza agl’infermi, o la pubblica istruzione. Perciò alla metà del mese d’ottobre di quest’anno, tempo assegnato all’evacuazione e chiudimento de’ conventi restati in essere per mezzo di leggi, decreti, o deliberazioni anteriori doverono abbandonare il loro monastero le nostre monache benedettine, dopo esistite per lo spazio di anni 299 (77). Ai Minori osservanti di S. Maria a Ripa (78) e ai Cappuccini convenne pure lasciare il loro convento (79): essendo il primo di questi sussistito per anni 327, il secondo per anni 202 dalla respettiva fondazione. Il monastero delle Domenicane fu con reiterate suppliche riservato per la ragione detta all’epoca del 1808. Il precitato decreto assegnava ai religiosi, e religiose tutto il mese di ottobre a deporre il loro abito monastico, minacciandosi ai contravventori grave pena per parte ‘del cristianissimo imperatore dei Francesi nostro sovrano.
Anno 1814.
Essendo vacante la sede arcivescovile di Firenze fino dal dì 31 dicembre 1809 I’imperatore Napoleone nominò a coprir la medesima monsignore Antonio Eustachio Osmond vescovo di Nancy nella Lorena, a cui il sommo pontefice Pio VII per giuste cause non solo non volle mai accordare I’istituzione canonica, che anzi coerentemente al cap. – Avaritiae caecitas – del concilio II di Lione, per mezzo di una sua decretale de’ 2 decembre 1810 diretta al vicario capitolare della metropolitana, dichiarò il detto vescovo incapace di ogni e qualunque giurisdizione. Venuto non ostante lo stesso vescovo a risedere, amministrava come intruso la chiesa fiorentina tanto nello spirituale, che nell’economico, contraddicendo intanto i più alla di lui pretesa giurisdizione, e negando obbedire a’ suoi comandi. Il degnissimo proposto della nostra Collegiata signor Michele Maria Del Bianco fu uno tra gli altri contradittori: e a nulla giovate essendo le forti e convincenti ragioni che ebbe di cosi diportarsi esposte in due erudite e dotte lettere scritte una al prelodato monsignore Osmond, l’altra al direttore di polizia di Firenze, fu per decreto del Governo condannato alla deportazione in Bastia di Corsica. Nella sera di Pasqua, che fu il 14 aprile 1811 il medesimo signor proposto venne arrestato; e nel giorno dopo fu condotto a Livorno, per indi imbarcare per quell’Isola. Ivi fu ora libero sotto la sorveglianza del Governo, ora in carcere per più mesi assieme con altri sacerdoti, che vi erano stati deportati (80).
Cessata finalmente la persecuzione colla detronizzazione dell’imperator Napoleone, e mutato governo in Toscana, il prefato signor proposto poté tornare dal triennale esilio alla sua patria, e alla sua chiesa. Ciò avvenne la sera del dì 30 aprile di quest’anno 1814. Il popolo esultante gli andò incontro in gran folla, e fra le acclamazioni, e gli evviva lo accompagnò fino alla chiesa. Il clero, e i parochi del piviere lo riceverono in abito corale alla porta; e giunto all’altar maggiore, dopo aver fatta una breve analoga allocuzione, fu cantato I’inno ambrosiano, o poi dal medesimo fu compartita al popolo la benedizione coll’augustissimo Sacramento, che era stato esposto su detto altare, con apparato della chiesa e illuminazione decorosissima. Nella detta sera per tal fausto avvenimento furon fatti fuochi di gioia per tutto il paese. Nel dì susseguente primo maggio, coerentemente alle disposizioni del nostro Magistrato comunitativo, fu fatta con decorosa pompa una festa di ringraziamento all’ Altissimo pel possesso preso in Firenze a nome del granduca Ferdinando III stato già nostro sovrano prima della rivoluzione delle cose (81). l rappresentanti la Comunità unitamente a tutti gl’impiegati del paese assisterono alla solenne messa, che fu cantata dal signor proposto; dopo la quale tanto gli uni che gli altri si recarono in corpo ad ossequiare il medesimo, esternandogli le più sincere congratulazioni pel ritorno alla patria e al governo della sua chiesa. Il Capitolo fece l’istesso terminate le funzioni di questa mattina. Nel giorno dopo il vespro fu esposto all’altar maggiore il ss. Sacramento, e dopo l’inno ambrosiano fu data la benedizione all’affollato popolo che era concorso a rendere al misericordioso Signore le debite grazie per la tanto sospirata mutazione delle vicende. Nella sera si godè d’una brillante illuminazione fatta in tutto il paese.
Nel 22 novembre di questo stess’anno, essendo per passare di qui l’amatissimo nostro sovrano il granduca Ferdinando, la prima volta dopo il suo ritorno in Toscana, dai rappresentanti la nostra Comunità fu decretato doversi ricevere con quei segni di umil vassallaggio, e nel tempo stesso di pompa esteriore, che fossero i più convenienti all’Altezza sua imperiale. Fu perciò ornato l’ingresso alla porta fiorentina con festoni di lauri, e di mortelle, e sulla stessa porta si osservava sostenuto da due genii il ritratto del Principe con vari trofei simboleggiante la sovranità. Eran pur collocati in questo luogo alcuni cartelli analoghi scritti in stil lapidario dalle dotte penne dei signori dottori Luigi Pandolfini maestro pubblico di belle lettere in questa terra. e Giuseppe Romagnoli ambi canonici della nostra Collegiata. Fuori di detta porta il Principe sovrano fu ossequiato dal nostro clero unito al suo capo, dal vicario regio e dal magistrato comunitativo; e fu introdotto in Empoli al suono di tutte le campane del paese, preceduto dalla nostra Banda istrumentale, e da dodici giovani a cavallo vestiti in uniforme militare. Tutta la via ferdinanda per dove passava il prelodato sovrano era parata co’ soliti tappeti alle finestre, e avanti il palazzo della Comunità, che era ancor esso ornato co’ festoni, vi eran disposte sei fanciulle tutte vestite di bianco, una delle quali era destinata a presentare al granduca un mazzetto di fiori, con un libretto in stampa di varie poetiche composizioni fatte da’ più eruditi soggetti del nostro paese, che furono secondo l’ordine ivi tenuto, i signori auditore Pietro Lami, canonico Luigi Pandolfini di sopra nominato, dottor Cosimo Salvagnoli Marchetti, dottor Lorenzo Maria Pierotti, avvocato Niccolò Lami, Giovanni Pandolfini, dottor Luigi Busoni già Maire al presente Gonfaloniere della Comunità eletto dal Governo, dottor Giovanni Ciampolini di cui avvi un epigramma greco. Il popolo, che in questa congiuntura accorse in gran folla, accompagnò il sovrano in mezzo alle acclamazioni e all’evviva (82) .
Anno 1815.
Per nuovo, benché può dirsi momentaneo sconvolgimento di cose in Italia, avendo dovuto lasciar Roma il Sommo Pontefice Pio VII assieme col sacro collegio dei Cardinali, si portò a Firenze per indi passare a Genova. Giunse pertanto a Empoli, proseguendo il suo viaggio, a ore tre dopo la mezzanotte del dì 29 marzo senza che si sapesse se non da pochi, non molto tempo avanti. Pur non ostante, datasi voce, vi si trovò buona quantità di persone, e fu accompagnato fino alla fine del borgo verso Pisa in mezzo a molti torcetti alla veneziana. Avendo ciò risaputo nella mattina il popolo empolese, fu assai dispiacente di non avere avuta la bella sorte di esternare i suoi religiosi ossequi, e doverosi omaggi al capo visibile della chiesa (83). Susseguentemente passaron di qui molti cardinali; due de’ quali essendo visi trattenuti per pernottarvi, furono complimentati dal superiore del nostro clero unitamente a vari capitolari. L’istesso pure fu praticato con altro cardinale, che nella sua breve dimora fatta in Empoli, si portò alla nostra Collegiata per ascoltare la santa messa.
Anno 1816.
Sebbene fino dal dì 14 dicembre 1814 le nostre monache benedettine incominciassero a rientrare nel loro monastero della S. Croce colle debite facoltà dell’Ordinario fiorentino, e sotto la direzione del degnissimo nostro signor proposto Michele Del Bianco; pure a quest’anno 1816 si dee assegnare il ripristinamento del medesimo monastero, perché in quest’anno fu fra gli altri approvato dai tre arcivescovi della Toscana deputati dal sommo Pontefice Pio VII al ristabilimento degli ordini regolari, e all’organizzazione dei conventi dell’uno, o dell’altro sesso in tutto il granducato, e di più autorizzati ampiamente dal medesimo pontefice a confermare i detti ordini, e conventi per mezzo d’indulto della sacra penitenzieria de’ 14 giugno 1816. Il numero delle religiose componenti il precitato convento delle Benedettine fu fissato esser di dodici (84): e perciò fu loro assegnata in tanti beni stabili un’ annua entrata di scudi 1440. Il signor Pietro Figlinesi d’Empoli (85), che avea dimostrato grande zelo e impegno per la riapertura del nostro convento de’ Cappuccini, per cui anche somministrò buona somma di danaro; uno zelo e un impegno molto maggiore ha impiegato perla nuova erezione del suddetto convento benedettino; mentre perché l’opera restasse compita secondo i comuni desideri oltre le ripetute istanze fatte acciò il medesimo fosse nel numero de’conventi da ripristinarsi, sborsò gran quantità di danaro pel riattamento, e abbellimento non tanto della chiesa, che dell’istesso convento, di cui perciò fu dal granduca Ferdinando III nominato Operaio.
In quest’anno pure dal medesimo sovrano fu posto nel numero de’ Conservatorii da ripristinarsi in Toscana a carico della corona, il nostro conservatorio della SS. Annunziata, che come si disse, era stato riservato dalla soppressione per grazia del governo Francese. Per lo che il Principe gli assegnò dal regio erario un’ annua entrata di scudi 1800 essendo stato decretato, che il numero componente lo stesse fosse di diciotto individui.
Anno 1817.
Dominava in quest’anno quasi per tutta l’Italia, e nella Toscana pure una malattia detta tifo per cui molti passavano all’altra vita. Anche in Empoli non pochi furono infetti da tal malore, che apportò a parecchi la morte. Si aggiunse in questo stess’anno una generale siccità di più mesi, per cui pativano assai le campagne, facendovi temere di scarsa o niuna raccolta. Per ottenere la liberazione da tali disgrazie, previo un triduo coll’ esposizione dell’augustissimo Sacramento, nel dì 24 aprile fu esposto nella sua cappella il SS. Crocifisso delle grazie, e nella sera di tal giorno, dopo recitata le preci analoghe a tal circostanza fu ricoperto essendovi intervenuto il reverendissimo Capitolo, il magnifico Magistrato, che fece un’ offerta di più libbre di cera, ed il popolo in gran numero.
Seguitava la malattia precitata a infierire generalmente; come pure generalmente seguitava il sereno dell’aria, non avendo per anche voluto il signore Iddio esaudire le comuni preghiere, che si facevano in ogni luogo. Fu perciò determinato qui in Empoli, che si ricorresse a lui con nuove suppliche, presentandole per i meriti di Maria SS. Immacolata. Onde nel dì 8 maggio giorno di giovedì fu esposta solennemente all’altar maggiore della nostra Collegiata l’Imagine rappresentante la Concezione della Vergine detta comunemente la madonna di S. Lorenzo, che si conserva nella Collegiata predetta, e nella sera del suddetto giorno fu dal nostro clero portata a processione per la Terra coll’intervento de’PP. Cappuccini, e Minori osservanti di S. Maria a Ripa, delle nostre compagnie laicali, e d’alcune del piviere, e del Magistrato comunitativo ancora. Furono contati in tale occasione numero 560 lumi fra torcetti, ceri e candele; e più ve ne sarebbero stati,se se ne fossero potuti trovare in maggior numero. La detta sacra Imagine fu tenuta esposta al precitato altare fino al dì 11 dello stesso mese giorno di domenica, in cui dopo il vespro fu cantato solenne Te Deum perché già il benefizio della pioggia si era incominciato ad ottenere, molto giovevole ancora pel buon esito del suddetto male contagioso (86). Continuando il tifo a infierire anco tra noi, per provvedere al bisogno della povera gente non tanto d’Empoli, che della Comunità, che veniva attaccata da tal malore, fu necessario moltiplicare i letti in questo nostro spedale di S. Giuseppe. E perché il male, come si è detto di sopra avea del contagioso, fu creduto espediente, che gl’infetti dal medesimo si tenessero separati dagli altri ammalati. Per lo che fu ridotto a corsia per collocarvi i letti per servizio degli uomini il gran terrazzo del detto spedale, che è dalla parte di levante, e per servizio delle donne, lo stanzone coll’altre stanze contigue al medesimo. terrazzo; ai quali luoghi era proibito l’accesso a chicchessia, eccettuati i curati, i medici, e gli assistenti. Sebbene poi il tifo s’incominciasse a scoprire in Empoli nel mese di marzo di questo stess’anno 1817 pure tali provvedimenti ordinati anche dal Governo coll’erezione di un locale addetto a ricevere chi era attaccato dal medesimo male, non si presero che nel mese di maggio. Dal dì 16 pertanto di questo mese fino al dì 20 del susseguente dicembre, in cui restò chiuso il detto locale, furono ricevuti nel medesimo non tanto d’Empoli che della di lui Comunità, ammalati di tifo uomini 103 de’quali ne morirono 11, donne 138 delle quali 14 passarono all’altra vita. La mortalità di coloro che soffrirono il detto male nelle proprie case fu con una quasi simil proporzione.
Anno 1818.
Nel dicembre di quest’anno restò terminato, ed aperto qui in Empoli il nuovo Teatro dell’Accademia de’ Gelosi impazienti eretto da’ fondamenti nel luogo dell’antico teatro descritto in questo a c. 59. Il disegno di questa fabbrica grandiosa, elegante, e perfetta in tutte le sue parti è dell’ architetto Luigi Digny” di Firenze. Le pitture della soffitta, del vestibolo, della volta del parterre, de’parapetti de’ casini e del sipario del palco scenico sono di Antonio Luzzi Fiorentino. Gli scenari furono coloriti da Luigi Facchinelli di Verona; Nella sala dell’Accademia e nell’altra contigua vi dipinse Giuseppe Mazzantini d’Empoli. La spesa di tutto questo lavoro, che ammontò alla somma di circa diecimila scudi, fu fatta del proprio dai componenti l’Accademia suddetta.
Anno 1819.
Ritornato in Firenze dal viaggio di Napoli, e di Roma l’imperator Francesco I (detto II avanti l’abolizione dell’impero germanico) nel portarsi a Pisa alla celebre luminara che fu fatta a di lui ossequio nel dì 13 luglio di quest’anno, passò d’Empoli nel giorno antecedente a ore 7 della mattina assieme col fratello Ferdinando III nostro sovrano. Il popolo l’ossequiò radunato per tutta la via ferdinanda, e nel borgo. E perché era precorsa la voce che sarebbe passato dopo la mezzanotte del dì suddetto, fu perciò ordinata ed eseguita una illuminazione alle finestre della predetta via e borgo: e in tal tempo il concorso del popolo fu assai più numeroso.
Nel decorso del giorno passò l’Imperatore con altri personaggi della famiglia imperiale (87).
Anno 1820.
Il dì 20 novembre di quest’anno furono aperte le nuove pubbliche scuole nel già convento di S. Agostino di questa Terra d’Empoli, il di cui stabilimento fu approvato con benigno rescritto di S. A. I. e R. Ferdinando III nostro sovrano sotto dì 13 febbraio di detto anno, participato al nostro magistrato comunitativo con lettera del Provveditore della camera delle comunità de’ 25 del medesimo. Le dette scuole son composte 1. di un lettore di logica e geometria, che esercita anche le funzioni di rettore delle scuole: 2. d’un lettore d’umanità e rettorica: 3. d’un maestro di grammatica: 4. d’un maestro, che insegna leggere, e scrivere, e aritmetica (88).
Nella mattina adunque del suddetto dì 20 il nostro reverendissimo Capitolo della Collegiata portatosi alla chiesa annessa all’Istituto assiste in abito corale alla solenne messa dello Spirito Santo celebrata dal degnissimo signor proposto Michele Maria Del Bianco, dopo di cui fu cantato l’inno ambrosiano in rendimento di grazie per sì consolante avvenimento. Assisterono pure a tutta la sacra funzione il vicario regio, il magistrato civico, i professori dell’Istituto, ed altri distinti soggetti. Terminata la funzione passarono tutti alle pubbliche scuole in mezzo ai musicali concerti della nostra Banda. La gran sala, una volta refettorio de’ frati agostiniani, ove esiste la biblioteca destinata al pubblico uso fino dall’anno scorso da monsignore arcivescovo d’Ancira Giovanni Marchetti nostro benemerito concittadino, vedeasi festeggiante per bene intesi ornati, e decorati dell’augusta imagine del sovrano posta sul trono. Quivi il Professore di belle lettere, rammentando que’ dotti, che onorarono con tante opere questa loro patria, animò con un discorso analogo i giovani empolesi a seguirne sì belli esempi.
Anno 1821.
Nel gennaio di quest’anno 1821 fu atterrata una delle quattro antiche porte d’Empoli, posta in capo della via del giglio verso levante. Siccome le dette quattro porte aveano sopra di sé alte torri dette anche torrioni, così al libro delle decime questa porta era descritta torrione posto nel terreno del toro. V’è chi pensa, che invece di terreno scritto così per isbaglio, dovesse dirsi torrione del toro, o porta del torrione del toro.
← PRECEDENTE SUCCESSIVA →
← PRECEDENTE SUCCESSIVA →
NOTE:
(1) Le sedici miglia pari a chilometri ventisei sono computate per la via del poggio, perché per la via nuova del piano la distanza d’Empoli da Firenze è di diciotto miglia pari a chilometri ventinove.
(2) Il traffico, che da questi nostri faccendieri si è sempre fatto in Empoli, comodamente per l’opportunità del fiume Arno diede motivo a Filippo Cluverio e dietro a lui al Lami nel precitato Hodoeporicon, di credere, che qui fosse il luogo che nelle tavole itinerario dicesi, portus e in portu, per la strada che va a Pisa. Ma il Lami corresse il suo parere nella prefazione latina di detta opera, con dire « opinio Gluverii. quod Empulum locus sit qui in tabulis itinerariis portus et in portu dicitur forte non subsistit, nam ex tabulis Peutingerianis, Florentiae proprior locus esse videtur; et proprius Florentiem collocatus est etiam in tabula geographica qua Dempsteriana Etruria regalìs instructa est ».
(3) Le colline prossime a Empoli, specialmente quelle verso mezzogiorno, oltre buoni frutti producono altresì ottimi vini. Il Redi nel suo ditirambo Bacco in Toscana, loda il vino di Monterappoli, e quello del Cotone detto pisciancio. Ed il nostro Pier Domenico Bartoloni, parimente nel suo ditirambo Bacco in Boemia, oltre ai suddetti loda il vino di Loro, del Pozzale, e di Granaiolo, luoghi tutti in vicinanza d’Empoli, a cui con estro poetico si volge con dire:
Buon píscioncio a te sull’Orme (a)
Si dispensi dal Cotone,
Ed a quel quasi conforme
Diane Loro, e liberale
Ne cimenti al paragone
Altrettanto anco il Pozzale.
E se il piscíancio è poco
A svegliarti il bel fuoco,
Per dar faci
Più vivaci
Spremer saprà più generosi grappoli
Granaiol non avaro, e Monterappoli.
E bonissimo ancora il vino di Samontana, di Prunecchio, di Val di Botte, e di Ponzano,i quali sono tutti
luoghi prossimi alla detta Terra d’Empoli.
(a) Orme è un fiumicello o torrente che sbocca in Arno poco discosto da Empoli.
(4) Empoli è stato sempre luogo di traffico, contribuendovi moltissimo, oltre la vicinanza dell’Arno, I’essere
in mezzo a Città e grosse Terre: come dice l’Anonimo, il mercato, che vi si fa ogni giovedì della settimana, è
uno fra i maggiori della Toscana. Il traffico degli Empolesi fu un tempo l’arte della lana, e ne profittarono a
segno, che molte antiche case del paese ripetono le loro ricchezze da simile manifattura. Dicesi, che le coperte di lana lavorate in Empoli, si commerciassero in tutto il dominio di Spagna, ed un personaggio di molto criterio asserì che a ciò allude il Cervantes nel suo romanzo, il Don Chisciotte, avendo a forma degli altri drammatici e compositori di commedie, lavorata su di tal fatto la sua favola. Vi è in Empoli da molto tempo una fabbrica di stoviglie molto accreditata (b) . Sebbene poi non appartenga direttamente a genere di commercio la esistenza in Empoli, da tempo immemorabile, del R. Uffizio del sale, che da Volterra, ove si fabbrica, condotto in questi magazzini, continuamente si spedisce quasi per tutta la Toscana, pure in questa occasione lo volentieri di ciò memoria, perché la Azienda del sale apporta grande utilità al paese, non solo per le persone impiegate e servienti a tale Uffizio, quanto ancora per quelli che per terra, o per Arno si occupano ne’ trasporti del medesimo sale.
(b) Questa fabbrica ora non v’è più. N. dell’E
(5) Da chi fosse edificato Empoli, ove è di presente, ed in che tempo, si dirà nel decorso della storia.
(6) Il nostro Anonimo scrisse la sua storia, come rilevasi dall’istessa, l’anno 1567. ln tal tempo dunque secondo il medesimo, esisteva la nostra pievania, già da 1106 anni avanti, cioè nel quinto secolo. I Lami nel tomo 4. dell’opera – Sanctae ecclesiae florentinae monumenta – non contradisse a questo sentimento ivi a c.101. – Siquis ejus (ecelesiae Empuli) coustructiouem saeculo quinto consignat non contradixerim…. saeculo nono ecclesia haec censum solvebat eccleaiae pisanae – e per questo appunto dall’anno 840 fino al 1012 si trova descritta per sei volte in un libro de censibus esistente nello archivio della chiesa pisana. Questa pieve fu chiamata propositura da Clemente VII nell’anno 1531. Il suo piviere è uno dei più vasti della diogesi fiorentina, avendo un circondario di circa diciotto miglia, pari a chilometri ventinove e anticamente comprendeva trenta chiese parrocchiali, tutte soggette al pievano d’Empoli, come si rileva dalla Bolla di Celestino III dell’anno 1192 e dall’altra di papa Alessandro IV dell’anno 1258 esistenti nell’archivio del nostro Capitolo, e sono le appresso, delle quali in oggi sussistono quelle sole, che sono numerate nel margine. L’ordine di queste chiese, è quello delle suddette Bolle, ma non ne decide fra queste la maggioranza.
S. Donnino presso Empoli, detto in Cittadella.
S. Lorenzo a Ripa.
S. Lucia tra Empoli e Ripa.
1. S. Maria a Ripa (a).
S. Donato.
S. Mamante a Empoli Vecchio.
S. Michele.
S. Stefano a Casciana.
S. Cristoforo a Streda.
S. Iacopo ad Avane.
3. S. Pietro a Riottoli.
S. Martino a Vitiana.
4. S. Cristina a Pagnana.
5. S. Leonardo a Cerbaiola.
6. SS. Simone e Giuda a Corniola (b).
SS. lppolito e Cassiano a Valle.
7. S. Giusto a Pretoio.
S. Ruffino in padule, ora presso i Cappuccini.
SS. Iacopo e Filippo a Piazzano.
S. Fridiano in Val di Botte.
8. S. Donato in Val di Botte.
9. S. Maria a Fibbiana.
S. Michele a Legnana.
10. S. Maria a Cortenuova.
11. S. Martino a Pontorme.
12. S. Michele a Pontorme.
S. Ponziano in Pratignone.
13. S. Maria a Spicchio.
14. S. Bartolommeo a Sovigliana.
15. S. Maria a Pretoio.
16. S. Michele alla Tinaia, eretta nell’anno 1786.
Anche il Capitolo di quest’insigne collegiata è antichissimo, trovandosi esistere fin dall’anno 1059 in una
Bolla di Niccolò II sommo pontefice, diretta al pievano Martino, e suoi cherici, viventi in comune. Il numero
degl’individui componenti il detto Capitolo è stato vario secondo i tempi. ln oggi vien composto dal proposto (prima dignità) dal decano e dall’arciprete, da dodici canonici ed inoltre da ventisei cappellani.
(a) La chiesa di S. Maria a Ripa, di patronato degli Adimari di Firenze, già unita al Capitolo d’Empoli, fu dai medesimi Adimari concessa nell’anno 1483 ai frati Minori Osservanti di S. Francesco, con consenso di detto Capitolo, i quali vi fabbricarono il convento con chiesa assai grande. Così dal campione beneficiale di detto Capitolo.
(b) La chiesa di SS. Simone e Giuda ai Corniola, unita già al nostro Capitolo, fu concessa dal medesimo nell’anno 1569 ai frati del Carmine che vi fabbricarono il convento e nuova Chiesa. Così dal campione beneficiale di detto Capitolo.
(7) Si è creduto, da molti che i marmi i quali adornano la facciata della nostra chiesa,fossero serviti per un arco trionfale fabbricato in onore di qualche antico re d’Etruria a piè del ponte a Orme, per la parte di Empoli. Così la pensò anche il Bartoloni nelle note al Bacco in Boemia. E se fu così, se ne osservano anche in oggi le vestigia, benché in gran parte sotterrate, in due fortissima muraglie le quali sono a piè di detto ponte, nelle quali il precitato Bartoloni credé osservarvi segni corrispondenti alla figura di quattro marmi grandi diafani, che si vedono tuttora nella suddetta facciata, giudicando di più che al medesimo arco appartenessero le due colonne antichissime, e di bellissimo marmo, che esistevano in essa chiesa presso la porta maggiore e che sostenevano i primi due archi della navata di mezzo, demolita dipoi nell’anno 1736. Dico solo, e pensi ognuno come vuole, che in occasione del riattamento e nuovo ornamento fatto alla facciata medesima nel 1802 furono trovati alcuni di detti marmi lavorati anche nella parte di dietro, ed in uno vi si leggeva, scolpito in caratteri romani – pacis – in un altro poi di detti marmi vi si leggeva scolpito in caratteri similmente romani – legionis – segno più che evidente che cotali marmi anche prima dell’anno 1093 erano serviti per un qualche grandioso edilizio.
(8) Il Lami nell’Hodoeporicon dice che il nostro autore «non pare che l’indovini, quando crede, che il vero antico nome d’Empoli fosse – Emporium – come ha dopo malamente creduto il lodato Cluverio, poiché essendo questa voce greca, per conseguenza non è adattata, e propria ad un luogo mediterraneo di Toscana, benché fosse conveniente alla qualità, e commercio del luogo. » E nella prefazione di detta opera dice, che anticamente questo luogo fu chiamato- Empulum – come consta da un libro in cartapecora dell’archivio della chiesa pisana: – Elpidius pleb. S. Andreae de Empulo, argentum denarii quatuor an. D. ad stil. Pis. 840 – e così negli anni 891 940 992 in detto libro Empulum, si dice pure in un libro del coro della nostra chiesa dell’anno 1445 ed in altro del 1491 ed in una certa scrittura del 1475 appresso il Gerracchini nei fasti teologici del Collegio fiorentino. Da Empulo poi ne fu fatto Empuli, e quindi Empoli siccome è detto negli strumenti degli anni 1255 1285 1325 1348 1356 1363 come dice il Lami nella suddetta prefazione, e così lo nominò Voglino di Giov. Da Empoli, che nell’anno 1382 scrisse un libro di Excerpti dello specchio istoriale di Vincenzio Bellovacense; così Ugolino Verino, così Sebastiano Sanleolini, uomini culti ed assai letterati. Nelle antiche scritture e cartapecore si trova ancora Empoli, Imporiae e Impori, tutti nomi corrotti da Empulum – Caeterum (Lami nella citata prefazione) lmpori ab Empulum factum est E in I, U in O facile transeuntibus: nam lmpoli in instrumento anni 1106 pronunciatur et proclive insuper est apud tuscos L in R convertere. – Da Impori poi mutato l’I in E se ne fece Emporium e trovasi così nel testamento di Melchiorre Rafffelli di Samminiato dell’anno 1519 e dal Bonincontri nel libro quinto della storia siciliana e da altri scrittori più recenti: – Quare (Lami come sopra) proclive fortasse fuit scriptoribus recentioribus vocabulum Emporium, confingere eo magis quod graecum esse videretur et oppido denominando congruum. – Si rammenta che la pieve di S. Andrea intorno a cui fu poi edificato Empoli nuovo come si dirà a suo luogo, fu detta la pieve al mercato – Caeterum Emporium nomen alicui oppido in Italia tributum reperire non erit, nisi generali signiticatu, quo locus aliquis mercatus esse denotetur. – Vi è stato, chi ha creduto, che il vero nome di questa Terra fosse Emappoli donde si è fatto il nome corrotto Empolis: ma di tal denominazione per quanto è a mia notizia non se ne trovano che due esempi; uno nel 1000 l’altro nel 1012 nel precitato libro in cartapecora della chiesa pisana. Il vocabolario di Torino, senza nessuno esempio di antichi scrittori Empoli lo dice latinamente Empolia.
(9) Che la chiesa di S. Mamante sussista in questo luogo fino dal sesto secolo, lo scrisse il Lami nell’opera Historiae Ecclesiasticae Florentinae monumentum tomo 3 a c. 88 anno 584. Per haec fortassis tempera ecclesia sancti Mamantis martyris ad Empulum, prope Arnum erecta fuit. Che fu poi riparata nell’anno 1232 come si legge in un cartello di marmo posto nella facciata della medesima. Questa chiesa appartiene al Capitolo d’Empoli fino dall’anno 1491.
(10) In un angolo della chiesa della facciata di S. Mamante d’Empoli Vecchio, si osserva anche in oggi un piccolo marmo bianco, molto ben lavorato con geroglifici di una testa di becco, il qual marmo fu ivi posto in occasione del risarcimento fatto a questa chiesa nell’anno 1232. Piuttosto che credere un tal marmo un avanzo dell’edifizio, di cui sopra ragiona il Manni, lo giudicherei ritrovato negli scavi fatti in questi luoghi, giacché non è molto, che di simili marmi ne sono stati dissotterrati anche altri frammenti. Il sepolcro di basso rilievo esprimente alcuna storia dei Romani si trovò nel distretto di Empoli, ove si diceva Cittadella, fu trasportato dalla chiesa di S. Rocco, dove era stato susseguentemente per alcun tempo collocato, a Firenze nel cortile di sua eccellenza il signore marchese Renuccini. Ivi pure vicino alla riva dell’Arno, fu scavata una iscrizione antichissima in marmo, ornata di pampani ed uccelletti, che l’eruditissimo signore abate Giuseppe Pierini di Livorno credé, siccome mi scrisse, posta ad un colombario, ossia ad una sepoltura addetta a racchiudere le ceneri dei defunti della famiglia Gavia. L’ha riportata il dottore Antonio Francesco Gori nel t. 1 delle iscrizioni della Toscana a c. 448 ed altre ancora, anzi il prelodato Gori fa vedere a tal proposito, che questi luoghi furono abitati da legioni Romane prima mai de’ Cesari. Detta iscrizione da gran tempo si osserva in una parte dell’oratorio di S. Michele a Dianella luogo non molto distante da Empoli di proprietà una volta della nobile famiglia Federighi di Firenze; ed è l’appreso, che per essere della gentilità, non saprei ridire il perché fosse collocata in detto sacro oratorio:
V. – R.
C. GAVIVS. L. F. ASPER.
L. GAVIO. Q. F. PATRI.
GRÆCIÆ. A. F. QUINTÆ.
MATRI.
A. GAVIO. Q. F. PATRUO.
L. GAVIO. L. .F. MANSUETO
FRATRI. – MIL. CHOR.
VIXIT. ANNOS. XXXVI
MILITAVIT. ANNIS. V.
Si noti qui di passaggio, che una parte della suddetta famiglia Federighi, venuta di Francia si fermò in Empoli, come scrisse Ugolino Verino nel libro III.
Ad nos misit Arar Federigos, altera quamquam
Empoli: etrusci pars prolis sedit ad arces.
(11) L’iscrizione di Luciano, la quale dicesi, che una volta esistesse a Pietra fitta copiata con esattezza mi fu gentilmente favorita dal signor senatore Amerigo Antinori ed è l’appresso:
T. QVINTIUS. T. F.
FLAMINIUS.
C. S.
PISAS.
In cui, siccome si osserva bene, vi mancano alcune lettere, cosi può essere che anticamente vi si leggesse ciò che vi è di più in quella di Uberto. Il Gori la produsse nel tomo 2 a carte 215.
(12) Le parole – AB. HINC. FINIS. EST. NOSTRI. EPISCOPATUS. ET. COMITATUS. PLEBIUM. – dal padre Matteiche riporta la memoria precitata d’Uberto nelle vite degli arcivescovi pisani, sono stampate in carattere diverso da quello degli antecedenti versi dell’iscrizione, onde pare, che non devano riferirsi a detta iscrizione, e ciò sembra rilevarsi ancora dal contesto della memoria. Intorno alla quale stimo bene avvertire, come il suddetto Mattei, ed il Lami che pure esso la produce nel t. 4. a c. 108 dell’opera sanctae ecclesiae Florentinae monumentum: la credono di dubbia fede. Comunque siasi per altro la scrittura è antichissima.
(13) Il Romagnoli promise di scriver la storia di Empoli, ma o non la scrisse, o scritta non la fece palese. Il Lami, ed il Manni ricorsero a lui per aver notizie di Empoli. Egli poi al dire dell’istesso Manni nell’anzi detto tomo ne aveva raccolte molte dagli scritti privati di ser Polidoro Polidori, e da altri della casa dei signori Del Papa, ambedue antiche famiglie Empolesi.
(14) Nel sigillo della lega vi si osserva in mezzo, in facciata della nostra chiesa Collegiata, che rappresenta l’arme della Comunità d’Empoli; a mano destra un monticello con alcuni grappoli e tralci pampinosi, lo che è il segno della Comunità di Monterappoli; o a mano sinistra un loggiato con torre alta ai guisa di campanile, che è I’antica divisa della Comunità di Pontorme, ed in carattere gotico ivi si legge – sigillu lighe de Empoli.-
Siccome poi la suddetta arme, non può esser più antica della facciata medesima che, come si disse altrove, vi fu costruita nel 1093 così vi è stato chi ha creduto, che per l’avanti la divisa di Empoli consistesse in alcuni sacchi, con entrovi piccole stellette. Si dice che allorquando gli Empolesi si sottomisero ai Fiorentini, aggiungessero a detta divisa un leone, come rampante sopra l’istessa facciata, e due gigli, l’uno a destra l’altro a sinistra, come si vede nel sigillo grande della Comunità di Empoli: sul che può vedersi il Manni tomo e sigillo suddetto. Questo leone si osserva ancora in un’arme di pietra di detta Comunità che in oggi si vede nel corridore, che dalla chiesa Collegiata porta alla chiesetta di S. Giovanni al batistero; ed é antichissima, mentre era posta nella navata di mezzo di detta chiesa Collegiata, che a spese della Comunità, e del piovano Pietro di Ugucciozzo dei Ricci Fiorentino, vi fu fatta e riattala nel 1394 come dal campione beneficiale del Capitolo.
(15) Quando deva credersi, che le predette tre Comunità facessero lega tra loro circa al tempo sopra indicato, non sembra per altro che da essa si sciogliessero all’epoca in cui gli Empolesi si sottomisero ai Fiorentini, come dice il Manni; anzi detta lega può giudicarsi confermata da questi per difesa del loro contado; mentre in « Estratto di registri di lettere della signorìa di Firenze a « diversi » che si conserva fra’ manoscritti della biblioteca pubblica magliabecana, si trova che l’anno 1327 Ad comitem de Punturmo scrivono che stia sicuro dalle cavalcate, essendosi comandato a Vermilio de Vicedominis capitano Lighae Empolis ed altri vicini di stare in guardia. Targioni tomo 1 storia d’Empoli.
(16) ln vicinanza di Pagnana presso l’Arno, alla distanza di circa tre miglia da Empoli, per la parte di ponente evvi un luogo, detto ancora la Motta. Motte si dicevano certe fortezze, fabbricato al piano, sopra una altezza di terra fatta a mano: dice il Muratori, annali d’Italia t. 6. a c. 93. Dai riscontri dei libri di questo pubblico si ha, che gli Empolesi tenevano il presidio alla suddetta Motta. Così il Romagnoli nei manoscritti.
(17) Si crede che le contese, di cui si parla, fossero per la causa di confini tra il Comune di Marcignana, e quello di Pagnana. Ma finalmente reperti fuere confines inter Commune hominum de Pagnan civitatis Florentiae et Commune hominum de Marcignana distructus Sancti Miniatis commumi concordia, et voluntate per ser Joannem not. olim Cursi de Pagnana oofficialem Communis Florentiae – et per ser Guidonem not. quondam Bonaventura officialem Communis S. Miniatis – l’anno 1287 il dì 25 di marzo indizione 15, secundum cursus, et usum civitatis Florentiae, e l’anno 1288 giorno, mese, ed indizione predetta – secundum cursum et usum S. Miniatis. L’Instrumento per intiero è riportato dal Lami nella prima parte dell’Hodoeporicon a c. 182 e nel tomo 1 sanctae ecclesiae florentinae monumentum a c. 335.
(18) Il suddetto Borgo era situato al di qua del Ponte a Elsa. In un diploma riportato nel suddetto Hodoeporicon a carte 118 si ha: Ex una parte Elsae versus levantem et territorium Burgi S. Fioris, a cui fu dato il guasto nel mese d’agosto 1336 da Ciupo degli Scolari capitano di Mastino. Così l’Ammirato a carte 405 del tomo I.
(19) Petroio o Pretoio è un luogo che resta sopra d’una collina a nord-ovest d’Empoli, di là dall’Arno circa a due miglia. ln antico era un castello, che Castruccio, signore di Lucca, venendo sopra a Empoli l’occupò, ed ivi messe il presidio il dì 5 di aprile 1326 come si ha nel tomo primo dell’Ammirato a carte 325. Pare che nel 1351 fosse tuttora in essere, perché nel campione beneficiale del nostro Capitolo, nella fondazione della cappella di S. Sebastiano si nomina in detto anno – un certo Antonio di Vaggio di Maria Giuseppe del Castello di Pretojo.
(20) Il Lami nel tomo quarto sanctae ecclesiae florentinae monumentum a carte 107 trascrive « germanorum filiorum Bosi. »
(21) La famiglia dei Conti Guidi, o Alberti: secondo il Targioni, si era ridotta debolissima a cagione di avere suddiviso i suoi stati « ln stirpes, et capita. » Perciò nel suddetto libro dei capitoli si legge che nel 1255 a dì 6 maggio il conte Guido, novello nipote di Guido Guerra vende al Comune di Firenze la quarta parte del « Palazzo Vecchio di Empoli, e del Castello di Empoli, e Monterappoli » Il conte Simone suo fratello ratificò la vendita, e cedè ancor egli le sue ragioni « A 1273 die Jovis 18 oct. comes Guido Silvaticus ›› vende la quarta parte Montis Murli, Montis Guarchi, Empuli, et aliarum terrarum de Greti. » Cosi il Targioni Viaggi, tomo primo Istoria d’ Empoli.
(22) De’ varii ordini, de’ feudi, vedasi il Calvino, lexic. iurid.
(23) Dall’osservi fatto in Empoli il suddetto congresso dei Ghibellini, non deve ritrarsene per conseguenza, che gli Empolesi fossero del loro partito; che anzi generalmente si tenevano per la parte Guelfa, come sudditi della Repubblica fiorentina. Perciò nell’anno 1324 il Comune di Firenze diede certi ordini per il governo dei Guelfi di Empoli perché avevano fatta certa riforma come dicesi nel libro Z. delle riformagioni a carte 89. Su di questo proposito vedasi il Targioni nel tomo primo dei suoi viaggi Istoria di Empoli.
(24) E fama che il sentimento dei suddetti congregati Ghibellini fosse di trasportare gli abitanti di Firenze a Empoli. Su tal proposito ecco ciò che scrive il suddetto Targioni « La situazione d’ Empoli sarebbe felice quanto mai uno immaginar si possa per una gran Metropoli in mezzo cioè d’una vasta, sana e fertilissima pianura ventilata a sufficienza circondata da fertili e deliziose colline, non troppo lontana, né troppo vicina ai monti più alti, sopra di un grosso fiume navigabile e non molto distante dal mare. Certamente qualunque volta io la considero non mi credo punto obbligato al famoso Farinata degli Uberti, perché solo a viso aperto impedì nel 1260 ti che si distruggesse Firenze, e che gli abitanti si trasportassero ad Empoli. Questa trasmigrazione sarebbe senza dubbio dispiaciuta ai nostri progenitori, ma per noi era desiderabilissima; poiché da quel tempo fino al presente Empoli sarebbe divenuta una città incredibilmente più bella e più salubre di quello che sia Firenze. »
(25) Il piano di Empoli ed il paese ancora è stato spesso soggetto alle inondazioni dell’Arno nei tempi passati. ln un libro di amministrazione dell’altare della Madonna, cosi detta, di S. Lorenzo a carte 71 leggesi, che nel mese di marzo del 1708 fu tale l’inondazione, che arrivò fino alle radici del poggio del Cotone, e perché le semente restarono allegate dalla bolletta, in quell’anno il grano costò lire 20 e 24 il sacco. Parimente nel 1740 a’ dì 3 dicembre fuvvi altra terribile inondazione, che arrecò danni gravissimi; ed in Empoli le acque si alzarono circa 4 braccia o metri 2,336 dal suolo presso il convento delle Domenicane, che era il luogo più basso prima del rialzamento della strada. ln oggi questo Paese, e la pianura all’intorno, non è tanto soggetta a tali inondazioni, mediante il rialzamento degli argini.
(26) Si potrebbe credere, che l’ ordine della Repubblica fiorentina non fosse stato di restaurare le vecchie mura d’Empoli, state danneggiate dal suddetto diluvio del 1333, ma bensì di riedificarle di nuovo. L’Ammirato infatti dice che dette mura fossero rifatte. Una grossa muraglia di antica fortificazione con due troniere da cannoni voltate verso levante, che fu trovata sotto l’oratorio di S. Giuseppe in occasione di essere stato ripavimentato nel 1805 favorisce questa nostra opinione; mentre della fortificazione non ha che fare niente colle suddette mura rifatte. Questo oratorio fu edificato qui in Empoli nell’anno 1640 nella via che ora dicesi di S. Giuseppe.
(27) Al tempo del signor canonico Lazzeri esistevano anco le due porte, una detta ad Arno, l’altra Fiorentina. Quella ad Arno fu demolita circa il 1830, l’altra l’anno 1838. Adesso non esiste che quella della Pisana. (Nota aggiunta)
(28) La torre dell’orto delle Benedettine fu demolita fino al pari dell’edifizio contiguo nel 1814.
(29) La Torre dell’orto delle Domenicana fu demolita affatto per ordine del granduca Pietro Leopoldo quando nel 1785 volle ridotto il convento a conservatorio.
(30) Nel luogo ove esisteva in Borgo il suddetto convento nel 1610 vi fu fabbricato un oratorio sotto il titolo di S. Antonio abate.
(31) Questa chiesa fu mancante per molto tempo di proporzionato campanile; ma vi fu eretto con bella architettura nell’anno 1686.
(32) Nell’anno 1799 epoca in cui dal dì 25 marzo fino al dì 5 luglio la Toscana fu soggetta al Governo della libertà, ed uguaglianza francese vennero a Empoli alcuni Saminiatesi a far viva istanza presso il cancelliere comunitativo acciò fosse tolto dal Tribunale il precitato chiavistello, che poi fece levar via uno di loro allorché fu mandato qua dal medesimo Governo in qualità di vicario. Ma partiti i Francesi di Toscana, il chiavistello fu subito ricollocato al suo posto ove al dir del Neri:
Dureranno sue glorie inclite, e rare
Finché mai un chiavistello può durare (a).
(a) Il detto chiavistello fu definitivamente tolto nel 1859 quando si recò in Empoli Giorgio Manganaro come Commissario del governo provvisorio della Toscana. N. dell’E.
(33) A tal proposito il detto Neri incomincia così il suo poema giocoso intitolato Il Saminiato:
Canto l’ eccelsa e singolare impresa
Di Saminiato, e il capitan Cantini
E canto la terribile difesa
Che fero i valorosi Cittadini;
Dirò la strattagemma ordita, e tesa
Di tante corna, e tanti lumicini,
E dirò come il vincitor drappello
Portò quel memorabil chiavistello.
Il nostro autore nel canto XII del suo poema fa derivare il nostro Volo dell’asino dalla risposta data da Silvera colonnella dei Saminiatesi all’empolese messaggiero, allorché le intimò la resa di Saminiato:
Cioè, che gli asin pria volar di posta
Si vedranno pel ciel da Battro a Tile
Che la forte Città coi suoi paesi
Cada in poter giammai degli Empolesi.
Onde presa la detta Città nel modo accennato, i senatori
Danno ordin che si debba il dì seguente,
Dal campanile un asino volare.
Prescindendosi per altro dalla poetica invenzione il Volo dell’asino, che segue qui in Empoli ogn’anno nella sera del Corpus Domini terminate le sacre funzioni, è uno degli antichi divertimenti dati per trattenere il popolo dal dopo pranzo fino all’ora di vespro. E a tal proposito mi sia permesso il riportare una elegia trovata in un libro della soppressa compagnia di S. Andrea, a cui appartenevano le spese occorrenti per il Volo di cui si ragiona
I. B. D. P. F. Q. S. sopra il Volo dell’asino.
Era nel dì di (Giove cinquecento
Mille, (e di giugno nove) cinquantotto
E la bandiera era spiegata al vento.
Eran passale l’ore già diciotto
Diciannove forse erano sonate
E l’asin viddi volar al di sotto.
Mirabil cosa parve alle brigate
Più che non è la nolle di Befana,
A tale aspetto ch’eran quivi state.
Il resto vi vuol dir mia mente insana
D’Empoli in sulla piazza qual si dette
Sollazzo molto alla gente villana.
Un alto stollo sempre ritto stette
Sopra del quale una bella berretta
Rossa collo spennacchio vi si mette.
Di molti per averla con gran fretta
A gara cominciavano a salire.
Ma tosto I’unto lor dava la stretta,
Talchè di risa quasi di morire
Mi venne voglia, pure io mi ritenni,
E volsi dalla piazza allora uscire.
Per giostrar già si davan molli cenni
Al saracin, che colle palle in mano
Nel voltarsi a chi corre lassa i segni.
Contro il suo scudo, quattro, o cinque invano
Corser con molti colpi per provare
Se la lancia sbattea lor dalla mano.
A certi fece quella divettare
Con dar lor di buon colpi sulla spalla,
Agli altri ancor la fa di manca scare,
Per premio v’ era posta becca gialla
E rossa, e verde stringa sproni e guanti
Di più colori come la farfalla.
Finita quella giostra poco avanti
Spogliati certi de’ lor grossi panni
A piè lo slollo corron di quei canti.
Volse fra loro uscir di tanti affanni
Un di via elliara, che con la pastoia
Montando su gli trasse de lor danni.
Così fini di tutti quella noia
Coll’aiuto di Dio, e dei suoi Santi.
Qual doni per gli altri anni molta gioia.
Finito che fu il giuoco tutti quanti
Rimessesi le vesti, ed i lor panni
Voltonno della piazza que’duo canti.
Un gallo vecchio più di millant’anni
legalo era per l’ali alla finestra
Di Tito de’Giannini, de’ Giovanni.
Quel matto che vago è della minestra,
Si pensò che strappare i piedi al gallo
Non altro fosse che sbarbar ginestra.
Co’ denti e colle mani, per un callo
Vi si attaccò con forza e con rapina
Ma il suo pensier divenne volto in fallo
Cotto non si sarebbe la mattina
Seguente, che era si ben fosse stato
Dell’ore più di dodici in cucina.
Un altro per averlo infuriato
Lo prese cogli ugnoni come un gatto
Tanto che l’ebbe tutto spennacchiato.
V’è dopo un altro visto questo tratto
Carpolli i piedi, e tirò tanto forte
Che quel che si pensò li venne fatto.
Cosi finì del gallo la sua morte.
Il saracino secondo il vocabolario di Torino « è una statua di legno a similitudine di un uomo saracino, nella quale i cavalieri correndo rompono la lancia. »
E tale poco più, o poco meno era anche il nostro; se non che invece delle gambe, sotto il corpo era perniato e girava su di un basso stile.
Anche gran tempo dopo che si era smesso il giuoco smesso il giuoco della giostra, come si dice nell’elegia e precisamente fin circa all’anno 1770, si poneva in piazza nella vigilia del Corpus Domini, e vi stava fino alla sera della festa. Intorno al medesimo vi si radunava di tanto in tanto quantità di ragazzi, che con atto di disprezzo e con urla girandolo lo chiamavano Il nonno degli Ebrei. Si dice che tal sorta di baiate si permettessero contro quella nazione di cui molte famiglie abitavano in Empoli anticamente, in aborrimento del sacrilego attentato commesso nell’anno 1518 dall’ebreo Zaccaria d’Isacco, il quale (siccome porta constantemente la tradizione) in tempo della solenne processione del Corpus Domini gettò sopra al baldacchino del ss. Sacramento, ed intorno al medesimo alcune schifose immondizie. Il perché dal Magistrato degli Otto di Firenze sotto il dì 16 giugno dell’anno suddetto si ordinò al Potestà di Empoli Domenico Parigi, come apparisce a c. 87 del di lui Civile esistente nell’archivio di questa Comunità che a spese del detto ebreo « per lo errore commesso qui nel dì della processione pontificale si erigesse un tabernacolo pubblico coll’immagine di Maria santissima, con iscrizione significante il fatto. »
Questa è quella Immagine di terra della Robbia che è posta quasi nella cantonata del palazzo pretorio, sotto la quale sta scritto: « Del prezzo degli Ebrei per loro errore ferno a lode di Dio far questa gli Otto sedente nel 18 Domenico Parigi qui pretore. » E si asserisce per certo che il lume che sempre si accende di notte tempo a questa Immagine a spese della nostra Comunità sia per fondo dato alla medesima dagli Ebrei a ciò obbligati dal suddetto magistrato in pena dell’accennato delitto.
Corre ancora questa tradizione, che loro fosse imposto di far mattonare a mattone a taglio tutta la piazza della Collegiata con i portici e loggiati della medesima.
(34) L’Ammirato nel libro XVI a carte 872 ed il Muratori nel libro VIII degli annali d’Italia, pongono in quest’anno 1399 molte processioni fatte specialmente in Toscana da compagnie di più migliaia di persone di ogni sesso, età e condizione vestite di bianco, coll’insegna per lo più di un Crocifisso, facendo lunghi viaggi, e furono contati non pochi miracoli come succeduti in tale occasione, a relazione del detto Muratori.
E assai probabile che i nostri Empolesi, ad esempio degli altri, prendessero anch’essi a fare la suddetta processione col loro Crocifisso molto più per essere liberati dalla pestilenza da cui, come si disse, era infettato il loro paese, essendochè in questo anno medesimo, secondo il Muratori, la peste fece fiera strage di popoli in special modo italiani.
(35) Con la dignità episcopale hanno decorato questo lor patria anco gl’infrascritti illustri personaggi: GIOVANNI GIACHINI canonico della nostra Collegiata, chierico di Camera e vescovo assistente di Pio II sommo pontefice. (Manni suddetto.)
PIER ANTONIO GIACHINI nostro canonico nel 1494. Nel 1529 vicario generale del Vescovo di Firenze, priore dipoi degl’Innocenti e canonico di Volterra e nel 1532 fatto vescovo d’Ippona suffraganeo di Pistoia. Morì nel dìi 15 maggio 1534. (Così il nostro campione beneficiale a carte 42, ed il Manni.)
Dottor GIOVANNI MARCHETTI, che nel 1814 fu consacrato arcivescovo in partibus di Ancira ed eletto istitutore primario di S. M. Carlo Lodovico Borbone già re d’ Etruria. Il detto Soggetto chiarissimo per molte opere in gran parte polemiche date alla luce era stato precedentemente per più anni presidente della venerabil chiesa del Gesù di Roma, espositore di sacra scrittura in detta chiesa, esaminatore apostolico del clero romano.
(36) Il Manni nel detto tomo 15 dice che le mura di Empoli furono fatte nel 1499. In un bastione vicino alla porta fiorentina demolito l’anno 1797 per comodo del giuoco del pallone furono trovate due epoche, una in fondo dell’anno 1476; l’altra in alto del 1505. Si possono tutte conciliare col riflettere, che un edilizio sì grandioso, che gira circa un miglio e che è formato solo di mattoni, e di tenacissimo calcistruzzo non potè perfezionarsi se non in più anni.
(37) Andrea Pazzi nei suoi poemi stampati parlando del prelodato canonico Giovanni, dopo d’avere intitolato l’epigramma «Fossae Emporii » dice:
Aspicis haec subita circumdata moenia fossa
Quae sestus decimus signat ab urbe Iapis?
Hoc est patanidae decus immortale Joannis,
Quì Terram bobus aruit arte nova.
(38) Fino circa l’anno 1775 si seguitò a chiudere notte tempo le suddette porte. Nell’anno poi 1785 dal nostro Magistrato comunitativo, composto per la maggior parte di persone non empolesi, fu progettata la vendita dell’imposte di legno delle medesime porte con molto dispiacere dei patrioti. Il progetto fu approvato dal Governo e ne fu ordinata I’esecuzione.
(39) Nell’anno 1811 essendosi fatto uno scasso nel terrapieno di della fortezza per fabbricarvi una nuova ghiacciaia vi furono trovati alcuni grossi muri di antica fortificazione. Ed in tale occasione fu anche osservato, che lungo il muro di detta fortezza verso tramontana vi era un cammin coperto a cui si scendeva dalla volta per alcune aperture. In mezzo a questo cammin coperto fu trovata una piccola porta murata, che corrispondeva dalla parte di fuori nel fosso delle mura.
(40) Il nostro Andrea Bonistalli soprannominato il Fracasso fu l’architetto di detta cupola, e di quel loggiato che circonda la chiesa. Tanto la cupola, quanto il loggiato che la medesima chiesa circonda fu costruito nell’anno 1621. Essendo questa chiesa mancante di adattato campanile, vi fu edificato nell’anno di nostra redenzione 1795.
(41) Il Giovio nel libro 18 delle sue istorie narrando l’assedio di Empoli dice che Andrea Giugni nuovo potestà del paese, era uomo affatto ignorante della guerra.
(42) Il detto autore scrive che dalla parte del Sarmiento che con i suoi Spagnoli stava accampato tra il fiume Arno e l’Orme, per la prima e principal cosa Calcella pugliese, maestro dell’artiglieria in pochi colpi ruppe le Mulina e le spezzò di modo che, opponendovi un argine, rivolse a man manca un canale d’acqua corrente il quale voltava le ruote e le macine, e poi empiva le fosse della Terra: e perciò le fosse essendogli tolta tutta l’acqua del fiume (Arno) si seccarono, e i soldati spagnoli si confidarono di potere entrar dentro da quella parte. É qui da notarsi che, forse perché in questo luogo l’Arno restava bipartito dal detto canale d’acqua, rimasi, al luogo medesimo il nome di Bisarnella, come si chiama anco in oggi.
(43) Il detto campanile è quello della collegiata unico in quei tempi: nella cui sommità vi fu fatto il ballatoio colla pergamena l’anno 1619.
(44) Già si disse che Diego Sarmiento si era accampato cogli Spagnoli di verso tramontana: il quale perciò da questa parte batteva la Terra. Dalla parte poi di ponente la batteva Alessandro Vitelli colle fanterie italiane come scrive il Giovio.
(45) Anco il Mecatti nella parte seconda della sua storia dice, che il campo nemico n’ebbe la peggio, e che fu sì fattamente ribattuto dai soldati d’Empoli, e dai Terrazzani che il Sarmiento si ritirò con animo di abbandonare l’impresa come impossibile a superarsi. Fra gli altri Empolesi che si distinsero in questa occasione si conta Socco Ferrante che come scrive il Manni nel tomo 15 dei sigilli, sigillo decimo, impedì l’entrata dei nemici dalle mura già rotte; per lo che gli fu fatta una statua che si conservò per del tempo nella nostra Collegiata.
(46) Il suddetto Tinto da Battifolle, Piero Orlandini ed Orbecco di Casentino capitani vecchi di fanteria, erano stati lasciati alla guardia d’Empoli dal Ferruccio prima di partire per Volterra. (Così il Giovio.)
(47) Scrive il Giovio che gli Spagnoli entrando nella Terra si trattennero alquanto nella fossa perché ne restarono impediti nel profondo dal tenacissimo fango; e cosi fangosi fino alla cintura s’aggrappavano; e aiutati per le mani di compagni passavano le mura. Il primo di tutti fu il Boccanegra il quale scendendo in casa dell’Orlandino giù per il tetto dove erano ricoverate quasi tutte lo più nobili donne e molte matrone fiorentine per esser più sicure, le spogliò di tutti gli ornamenti loro insino ai vezzi, le anella e le corone. Il contrordine poi del sacco dato dal Marchese Del Vasto, non pare che avesse effetto, perché in un giornale A del Capitolo della nostra chiesa a carte 40 si dice, che essendosi trattenuti gli Spagnoli in Empoli fino al dì 3 del prossimo settembre ebbero tutto il comodo di saccheggiare e portar via ogni mobile, panni lini e lani in gran quantità e danaro infinito, oltre i grani già detti di sopra con ritrovare ogni segreto. Fu saccheggiato ancora la sagrestia di detta chiesa, a cui poi per ordine del Sarmiento fu restituita molta sacra suppellettile ma molta si perdé, e si perderono pure due preziose Reliquie, una della S. Croce; l’altra d’una spina della corona del nostro Signor Gesù Cristo; le quali, incluse in due bellissimi reliquiarii, erano state donate dal nostro canonico Francesco di Giovanni Brancadori nell’anno 1495 come costa dal campione beneficiale del Capitolo a carte 43.
(48) Il detto spedale era destinato a dar ricetto ai pellegrini, e la compagnia di S. Andrea vi manteneva otto letti in buon ordine, ed eleggeva uno spedalingo il quale soprintendesse al medesimo. Era sotto la cura e governo della medesima compagnia un altro spedale di pellegrini detto di S. Maria delle Grotte, che esisteva nel borgo di Empoli verso ponente sottoposto allo spedale del Bigallo di Firenze; alla qual compagnia fu unito nel dì 5 ottobre 1566 per Bolla di Antonio Altoviti arcivescovo fiorentino. Questo poi restò soppresso per decreto dell’imperatore Francesco l granduca di Toscana e livellato co’ suoi beni il dì 20 marzo dell’anno 1751, a favore del detto spedale del Bigallo di Firenze, come si riscontra dal campione beneficiale e dai libri della precitata compagnia di S. Andrea.
(49) Il suddetto provento delle porte e della piazza continuò fino ai primi tempi del granduca Pietro Leopoldo cioè fino circa all’anno 1770. Nel 1809 il Governo Francese allora dominante voleva ripristinare le gabelle alle suddette porte; e perciò furono fabbricati presso le medesime certi casotti per comodo dei gabellieri; ma attesi alcuni giusti motivi l’ordine fu revocato. Fu per altro comandata una imposta a vantaggio di questa Comune da esigersi da chiunque esponeva generi vendibili nei giorni di mercato e di fiera e fu data in appalto per franchi 2083 che formano lire toscane 2480. La detta imposta cessò, mutato governo, nell’anno 1814.
(50) Credesi che detto Monte Pio sia stato successivamente in Empoli in più luoghi. In Via Chiara sulla porta di una casa vi è anche in oggi dipinta una pietà, solito stemma di tali Monti (a); In Via Ferdinanda ve ne è un’ altra di queste pietà, solito stemma di tali Monti; e nella stessa via un antico casamento vicino alla piazza si chiama anche in oggi «Monte vecchio». Ma tutti questi locali essendo troppo angusti per la azienda del medesimo Monte che, come sopra dicemmo, sempre più andava aumentandosi, fu trasferito dove è di presente cioè nelle vaste stanze terrene della Cancelleria, che era in antico un’osteria detta «della cervia» di proprietà della famiglia Ticciati d’Empoli, da cui la Comunità a spese del Monte la prese a livello.
(51) Nell’anno 1799 in cui i Francesi s’impadronirono per la prima volta della Toscana, Gualtier loro generale ordinò nel mese di giugno, che tutti i Monti di Pietà restituissero gratuitamente quei pegni che ritenevano dalle lire 10 in sotto. Il nostro Monte rese numero 14,757 pegni, che importarono la somma di 9006 scudi. Questa francese generosità fu sommamente dannosa alla povera gente, che sino d’allora intese bene le conseguenze funeste, che ne sarebbero provenute mentre per tale enorme scapito il detto Monte non potè per molti anni somministrare che poche lire anche su i pegni di molta valuta e per supplire al presto fu costretto a prendere del denaro a frutto.
← PRECEDENTE SUCCESSIVA →
← PRECEDENTE TORNA ALL’INIZIO
(52) L’oratorio di S. Rocco posto sulla strada pisana e lucchese poco distante da Empoli, verso ponente, fu eretto nel 1224 colle pie oblazioni del piovano, del capitolo e d’altre persone di detto luogo. Fu poi ceduto alla nobil famiglia Valori e quindi pervenne in quella dei marchesi Rinuccini di Firenze. Campione beneficiale del Capitolo a carte 141.
(53) Suor Maria Anna Del Bianco visse in detto convento e vi morì in concetto di santità il dì 19 novembre 1644. E nel dì 26 dicembre 1679 vi morì santamente una delle dodici fanciulle fondatrici, d’origine fiorentina, che alla religione si chiamò suor Ottavia Angela Arditi. Il Brocchi sul fine del primo tomo delle vite dei Santi e Beati fiorentini, onora l’una e l’altra col titolo di venerabili. Della prima esiste la vita manoscritta presso le monache del medesimo convento; della seconda si trova stampata fino dal 1739 e se ne vedono anco i ritratti.
(54) Il detto convento fu chiamato conservatorio dal granduca Pietro Leopoldo il dì 13 agosto 1783 e perciò vi furono aperte le pubbliche scuole per l’educazione cristiana delle piccole fanciulle del Paese e per il loro ammaestramento nei lavori donneschi. Fu anche dal medesimo Principe accresciuto nella fabbrica e delle entrate.
In proposito della pietà delle prelodate due religiose di questo convento stimo opportuno far qui menzione di alcun’altre persone illustri in santità, del nostro Paese e sono:
La B. BARTOLOMMEA BERTINI terziario de’ servi, nata qui in Empoli l’anno 1570 morta dipoi in Siena, ove si congiunse in matrimonio, il dì 17 giugno 1619. Di lei si trova la vita stampata l’anno 1626 e ne esiste il ritratto con questa iscrizione: B. Bartolomma Bertini da Empoli, dell’ordine dei servi. discepola del B. Pietro Berti del medesimo ordine.
La serva di Dio ANNA MARIA CIACCHERI, vedova del già depositario Giuliano di Donato del Riccio d’Empoli, detta della Croce, terziaria francescana del convento di S. Pietro d’Alcantara dell’Ambrogiana. Di questa servo di Dio esiste pure la vita manoscritta.
FRANCESCO MARIA DA EMPOLI francescano riformato: dei quali se ne tratta dal Brocchi e dal Manni. Il Manni poi annovera fra i nostri Santi il B. Iacopo di Giambono Giachini, e dice esser l’istesso che quell’Iacopo Giambono che visse e morì in Firenze con fama di santità nel 1345, come scrive l’Ammirato lib. X a carte 492. Lo stesso si legge nell’annotazioni stampate all’iscrizione sepolcrale del cavaliere Giambattista Giachini conte Sandonnini, posta nella chiesa di S. Maria n Ripa. Il detto Manni fa di più menzione della Lucrezia madre di S. Filippo Neri, della quale parla una decisione dell’auditore Finetti in causa Giachini e Galli In emporiens. benef. ove la detta Lucrezia si nomina Filiam Antonii « a Mosciano, qui erat ex hac familia (de Giachini) et erat frater germanus Joannis olim Andreae de Malepa. »
Ma poiché l’autore delle suddette annotazioni mette ciò in dubbio, lascerassi a suo beneplacito la cosa nel suo essere. Il soprannominato Brocchi nella storia anzi detta dei Santi fiorentini fa menzione ancora di altre persone celebri in santità, che sono: Ven. Ubaldo da Empoli dei Guardini sacerdote cappuccino.
Ven. Sisto da Empoli laico cappuccino.
Ven. Francesco Maria da Empoli frate riformato.
Ven. Bucarelli che per la predicazion del Vangelo subì il martirio nell’estere nazioni.
B. Bartolommeo Anghiari francescano domiciliato e morto nel convento di S. Maria a Ripa.
Ven. Paolo Filippo Boldigiani proposto dell’insigne Collegiata d’Empoli.
(55) Della quale epigrafe eccone la versione
AD ETERNA MEMORIA
DEGL’ILLUSTRI CITTADINI
DOTTOR IPPOLITO E PIETRO NERI
CHE AL PUBBLICO ESERCIZIO
DELL’ARTE DRAMMATICA
AD INFORMAR RETTAMENTE I COSTUMI
A GLORIA DELLE VIRTU’
DI BUON GRADO DEL PROPRIO AGLI EMPOLESI
LUOGO ADATTO DONARONO
IL DOTTOR LORENZO E FRANCESCO
FIGLI DELLO STESSO IPPOLITO
PER REVERENZA ED AMORE
P.
(56) In quest’anno 1816 i venti Accademici di detto teatro deliberarono di associare alla loro Accademia altri sedici soggetti di famiglie onorate del Paese in vista della spesa non indifferente da farsi pel nuovo ingrandimento e ornamento del medesimo teatro. Trattandosi di accademie è da sapersi, come scrive il Manni nel tomo 15 dei sigilli sig. 10, che qui in Empoli fiori fino al secolo XVII una rinomata Accademia delle lettere detta delle Cene, alla quale si trovano indirizzate alcune lettere stampate col titolo di « Lettere dell’abate Gio. Francesco Raimondi alli signori accademici delle Cene in Empoli » a carte 129 e 149. Scritti a penna alcuni componimenti in essa Accademici recitati esistevano presso il dottor Bartolommeo Romagnoli cappellano della nostra insigne Collegiata.
Un’altra Accademia non letteraria ma di giuoco pubblico si mantenne in Empoli fin circa la metà del seolo passato. Essa aveva le sue stanze in via detta del Pesco, ora comunemente delle Conce. Nell’ anno 1815 fu qui in Empoli istituita un’Accademia di canto e di suono, i cui individui presero il nome di Filarmonici, che per altro non durò molto.
(57) Le compagnie di S. Lorenzo e di S. Andrea, della S. Croce e della santissima Annunziata siccome concorrevano colla Comunità allo stipendio del maestro di scuola così prendevano parte per mezzo dei loro ufiziali, nell’elezioni e conferma del medesimo. Anzi sebbene il secondo maestro fosse stipendiato dal primo, pure l’elezione e la conferma anco di questo secondo si faceva dalla Comunità, coll’intervento e consenso degli ufiziali di dette compagnie.
(58) Dopo l’erezione del nostro spedale di S. Giuseppe fabbricato e mantenuto a spese dell’eredità Del Papa, le suddette doti lasciate dal Testatore in numero infinito sono ridotte per la nostra Comunità al numero di trenta che possono per altro aumentarsi, aumentandosi le rendite della suddetta eredità. E perché non restasse defraudata la volontà del Testatore circa I’aver nominati per l’avanzo delle doti gli antichi due Vicariati di Samminiato e di Certaldo, per decreto del Sovrano furono fissate annualmente quattro doti per ciascheduno dei detti vicariati, estraendosi a sorte ogn’anno un popolo per vicariato per godere delle medesime.
Parlandosi poi di doti, credo bene accennare che il nostro Capitolo, conferisce annualmente a una fanciulla della cura d’Empoli una dote di scudi 10, lasciata dalla felice memoria di Vincenzio Lippi di detto luogo, con suo testamento dell’anno 1600.
Un’altra dote di scudi 10 ogni due anni si conferisce a una fanciulla nata in Empoli e di padre e madre empolesi, dall’Opera della nostra chiesa, come ereditaria dei beni dell’antica compagnia della SS. Annunziata, a cui apparteneva la concessione di questa dote. Quattro doti di scudi 10 per ciascuna si conferiscono a benefizio di quattro fanciulle di tutto il Piviere d’Empoli estratte a sorte ogn’anno dalla compagnia di carità di questa cura; le quali doti furono assegnate al nostro Piviere dal granduca Pietro Leopoldo nell’istituzione delle compagnie di carità l’anno 1785.
Tre doti ognuna di scudi 10, con più una veste di lana si conferiscono a tre fanciulle empolesi dalla nobil famiglia dei marchesi Feroni di Firenze, discendente da Empoli, lasciate per testamento.
Due doti finalmente di lire toscane cinquantotto per dote si concedono a due fanciulle empolesi da queste illustri famiglie Ricci, eredi di Leonardo Ricci d’Empoli in ordine al di lui testamento dei 24 aprile 1717.
(59) Di questo e di alcuni altri illustri cittadini empolesi verranno pubblicate le biografie.
(60) In occasione di aver parlato del dottor Del Papa uomo eruditissimo, che il rinomato marchese di Caumont francese in una sua lettera lo chiama « ornamento non solo d’Italia, ma di tutto l’Europa ancora » come scrive il prelodato monsignore Fabbroni, stimo bene il riferir qui una mano d’uomini illustri in lettere di questa nostra Terra, disposti per ordine alfabetico, come gli riporta il Manni nel tomo 15 sigillo X, e primieramente il celebre
ALESSANDRO MARCHETTI professore di mattematiche nell’università di Pisa, filosofo, medico e poeta « sed qui ea facultate abusus est in ltalice vertendis impiis T. Lucretii Cari libris » dice il Lami tomo 4 a carte 139 S. ecclesiae florentinae monumentum. Che il detto Alessandro nascesse in Empoli ai 7 febbraio 1624 nella casa di abitazione dei signori Romagnoli, come accenna il Manni, non par vero, perché monsignore Fabbroni, che scrive la sua vita nella precitata decade quarta dice, che nacque in Pontorme il dì 15 febbraio 1632 e che mori in età di anni 82 nel 7 settembre 1714 come si legge ancora nell’iscrizione sepolcrale posta nella chiesa di Pontorme.
Perciò bisogna dire, che quell’Alessandro d’Angiolo Marchetti che dal libro dei battezzati della nostra chiesa trovasi nato in Empoli il dì 7 febbraio 1624, fosse un fratello maggiore dell’altro Alessandro di cui si ragiona.
Il Bartoloni nelle note del Bacco in Boemia asserisce, che detto Alessandro è originario d’Empoli sebbene da alcuni favoleggianti riputato pontormese, perché nacque e morì in Pontorme nella sua abitazione di villa; onde nel medesimo Ditirambo a tal proposito così si esprime:
Ma dimmi Empoli or tu come permetti
Che oggi colà di quel torrente in riva
E in faccia tua si ascriva
Tutto a Pontormo il non men tuo Marchetti?
Ah! non tanto soffrir; troppo si nuoce
A tue glorie, ed al vero:
Alza pur tu la voce,
E svela il fonte, onde da te deriva
Questo novello Omero,
Fu accademico ancora delle Cene.
ANDREA DA EMPOLI AGOSTINIANO, penitenziere del pontefice circa l’anno 1543. Lettore di teologia nella celebre università di Padova e fondatore del convento di S. Maria a Ripa di Monte Catini circa l’anno 1533. Di lui il Cerracchini ne favella nei fasti teologali a carte 224 per essere stato ammesso fino dal 18 giugno 1515 nell’università dei teologi fiorentini come baccelliere a leggere sul maestro delle sentenze.
ANTON FRANCESCO CAVALLI francescano teologo del cardinal Leopoldo dei Medici e gran predicatore, morto l’anno 1656 e sepolto con nobile iscrizione posta nella chiesa di S. Maria a Ripa, in cui viene appellato principe dei teologi in Italia.
ANTON FRANCESCO GIOMI lettore di legge civile nell’università pisana, sepolto con iscrizione nell’insigne collegiata.
ANTONIO DI GIOVANNI GIACHINI canonico fiorentino e priore di S. Maria maggiore, come si legge nel battistero di marmo da lui fabbricato nella nostra chiesa di S. Giovanni l’anno 1447. Al medesimo Niccolò V per suo breve dà facoltà di riconoscere, se vero è l’esposto da Maria dell’Albizi, che si possa fondare il monastero di S. Chiara di Firenze.
ANTONIO DI SER NICCOLÒ GUIDI, uomo erudito in lettere fu spedalingo di S. Paolo in Firenze l’anno 1528.
ANTONIO MESSERINI sacerdote, autore di varii componimenti eccellenti in stil bernesco. Vedi più sotto: Ottavio.
ANTONIO PELLICINI detto dal Negri per isbaglio Pelliccini, che scrisse dei mali contagiosi e pestilenziali per comando del Sovrano della Toscana nella peste dell’anno1630.
BARTOLOMMEO SALUTII, minore osservante di S. Francesco, che diede alle stampe panegirici, prediche, ed alcune opere scritturali.
BENEDETTO BUONSIGNORI, che essendo nelle lettere latine e greche versato, compose varie opere rammentate da Giulio Negri e fu abate della badia di Firenze. Questo asserì il più volte citato dottor BARTOLOMMEO ROMAGNOLI che nacque in Empoli, essendo infatti empolese la famiglia Buonsignori. Di lui parla il Puccinelli della badia fiorentina trattando.
DOMENICO DA EMPOLI, fondatore del monastero di monache al borgo a S. Lorenzo, di cui si ragiona da Alessandro Ceccherelli, nell’azioni del duca Alessandro Dei Medici. Vedi di esso più sotto.
DOMENICO VANGHETTI, mirabile filosofo nell’università di Pisa, sepolto con Pappreaso iscrizione, fatta dal celebre Lazzaro Benedetto Migliorucci, nel Carmine di Pisa:
DOMENICO VANGHETTI. EMPORIENSIS
JURIS. UTRISQUE. NEC. NON. PHILOSOPHIAE.
AC. MEDICINAE. DOCTORI.
SUBLIMIS. INGENII. VIRO. QUI. IN.
PISANA. UNIVERSITATE.
ANNIS. XXXVI.
PLAUSU. SUMMO. PHILOSOPHIAM. DOCUIT.
EX. GEOMETRIA.
VIM. RATIOCINANDI. MUTUARI. SOLITUS.
IN. MORIBUS. EXEMPLI. SINGULARIS.
CANDORE. ANIMI. INTEGRITATE. PRUDENTIA.
INSIGNIS.
INFAUSTO. CORREPTUS. MORBO.
PISIS. DECESSIT. ANNUM. AGENS.
LXIII.
FRATRES. LAURENTIUS. MILITIAE. DUX.
ET. JULIANUS. CANONICUS.
MONUMENTUM. HOC. MOERENTES. POSUERUNT.
ANNO. MDCCXXII. REPARATAE. SALUTIS.
ENEA GALLETTI decano d’Empoli autore di varie letterarie fatiche, alcune delle quali sono alle stampe, rammentato dal chiarissimo Giovanni Lami nel suo viaggio. E’ sepolto nella Collegiata, con iscrizione perita nel risarcimento della stessa chiesa. Vedi di esso più sotto.
FILIPPO DI MATTEO FERRINI, vicario generale del cardinale Antonio Pucci vescovo di Pistoia e a lui successore nella propositura d’Empoli; esso godè di molti titoli onorifici, che si leggono nell’iscrizione sepolcrale posta nella nostra Collegiata. Del medesimo disse qualche cosa il Manni nel sigillo II del tomo XIII.
MONA FIORE, della quale si conservano alcuni componimenti piacevoli dal sopra lodato dottor Romagnoli. FRANCESCO DA EMPOLI dei minori conventuali, detto ancora da Firenze, che scrisse a favore dell’erezione dei Monti Pii, provando esser lecito l’interesse dei medesimi. Di lui parla Scipione Ammirato nel libro XI a carte 562 delle sue istorie, nominandolo maestro Francesco da Empoli dei frati Minori nell’anno 1353.
FRANCESCO DA EMPOLI, detto anche da S. Simone di Pisa pure minorita, autore di alcune dotte opere, di cui parla il Tossignano, il quale aggiunge che floruit Oxoniae.
FRANCESCO TANI pievano della Collegiata nel 1523 dipoi vicario generale del vescovo di Troia nel Regno, ove mori nell’anno 1528, di cui parlò il Manni alcuna cosa nel sigillo II del tomo XIII.
FRANCESCO VANNOZZI, che ebbe una delle prime cattedre di Legge civile nello studio fiorentino, rammentato dal Migliore nella Firenze illustrata, fratello di Andrea Vannozzi, che fondò un canonicato nella Metropolitana fiorentina e ne fu egli il primo possessore. Del detto Francesco scrive altresì il Manni nel tomo VI a carte 97 che fu figliuolo di Iacopo di Francesco Vannozzi da Empoli e che fu cittadino ed avvocato fiorentino e che a lui appartenne la sepoltura che si trova sulle scalere della Metropolitana fiorentina a piè del campanile dalla parte del Bigallo ove si legge:
S. DNI. FRANCISCI. DE. EMPOLI
ET. SUOR.
Questo Francesco essendo come si è detto figlio d’Iacopo, viene ad essere diverso da quell’altro Francesco figlio d’Andrea che fece la sepoltura dalla parete della canonica, lungo la detta chiesa Metropolitana, dalla parte della canonica dove sta scritto:
S. FRANCESCO. D’ANDREA …MPOLI.
ET. FILIO. SUO.
dovendosi supplire DA EMPOLI alla mancanza d’alcune parole nel marmo, secondo il Richa e secondo l’autore della Firenze antica e moderna illustrata tomo II che riporta le dette iscrizioni.
FRANCESCO ZEFFI canonico d’Empoli, nel 1530 e di S. Lorenzo di Firenze e accademico fiorentino, autore di vari componimenti dei quali si parla nelle note letterarie, ed istoriche dell’accademia fiorentina e dal Negri negli scrittori fiorentini, come autore d’alcuna traduzione. Il famoso monsignor Vincenzio Borghini che fu suo discepolo lo domanda uomo letteratissimo e racconta delle sue lezioni di lettere latine e greche; come il Manni ha già toccato nel tomo III a carte 84 e a carte 86.
GIACHINO SANDONNINI professore di sacri canoni nell’università di Pisa e canonico della Primaziale. Nel 1751 diede alle stampe in Firenze un operetta che dedicò al Pontefice Benedetto XIV col titolo « Jachini Sandonnini in pisana academia juris canonici professoris de vera a ratione ob quam gradus cognationis in causis connubialibus non secundum leges, sed secundum canones computandi sunt. Dissertatio apologetica adversus osores obtrectatoresque canonicae computationis » di cui un estratto vedesi nelle Novelle letterarie fiorentine del 1786 n.° 35. Il prelodato canonico Giachino fu l’autore dell’annotazioni stampate nel 1780 all’iscrizione sepolcrale del cavaliere Giambattista Giachini, conte Sandonnini, altra volta citato, in cui dimostra a lungo la nobiltà di detta famiglia Sandonnini e la discendenza della medesima dai Conti della terra o castello di San Donnino della Garfagnana, del quale furono spogliati da Castruccio Antelminelli nel 1319. Da un diploma dell’imperator Carlo IV dato in Norembergh il dì 30 marzo 1736 a M. Andrea figlio d’Ugolino conte di San Donnino si ha che questa famiglia trae l’origine dai Re dei Longobardi, eccone le parole « Ut antiquissimae familiae tuae origo, et nobilitas sit omnibus in comperto, te Andream ex comitibus Sancti Domnini de Garfagnana a regio Longobardorum sanguine procreatum esse noscimus, et affermamus. » La stessa famiglia fu ascritta al senato di Lucca, ed ebbe 72 anziani e 14 principi di quella repubblica. Da Pio II fu decorata della Nunziatura di Francia, da Paolo II della mitra di Modena, e del Governo di Monte-Cassino nella persona di Niccolao l’anno 1465: da Sisto IV del chericato di camera e del paglio di Lucca, al di cui vescovado passò il detto Niccolao l’ anno 1479: e da Innocenzio VIII del governo del patrimonio. Fu restituita dal duca di Ferrara Ercole I nel possesso di S. Donnino e dai Pisani fu ammessa alla loro cittadinanza, ed onorata dell’arme della repubblica, come rilevasi dalla – scrittura di ragioni col sommario delle prove di fatto nell’Emporiens. habitus – stampato in Firenze nel 1736.
Secondo le notizie manoscritto esistenti presso questa casa Neri, un ramo di questa nobilissima famiglia, che s’era rifugiata in Lucca dopo la decadenza della Contea diede origine alla casa Sandonnini a Empoli, perché il conte Mattia di Giovanni di Carlo d’Andrea d’Ugolino conte di S. Donnino venne da Lucca a stabilirsi in Empoli con sua famiglia, raccomandato dalla Repubblica fiorentina come – nobile, valoroso soldato benemerito della medesima repubblica, aderente del popolo e zelante dalla parte Guelfa – al potestà d’Empoli Niccolò Carducci, con lettera del 7 febbraio 1491 riportata nel civile del detto potestà esistente nell’archivio della nostra Comunità, o Cancelleria e perché come parziale de’ fiorentini quando fu scoperta la macchina di Nese Franchi si era partito di Lucca nel 1490: di consiglio della medesima repubblica, fu perciò da essa provvisto d’un annuo stipendio: il nostro conte Mattia terminò in Empoli la sua vita e fu associato alla Collegiata con funerale sontuosissimo, di cui eccone la descrizione come sta registrato nel libro dei morti che si conserva in quest’archivio dell’Opera: M. Mattia di Giovanni di Carlo, conte di S. Donnino di Garfagnana, uomo d’arme, stipendiato dalla repubblica morì per insino a dì 27 novembre 1498 fu sepolto alla chiesa di S. Donnino fuor della porta con pietra ed iscrizione e con grandissimo onore. Furono al suo mortorio il Capitolo a d’Empoli e tutti i preti del Piviere. La Congregazione di Montelupo, e i frati di S. Agostino. e i frati di S. Maria delle grazie osservanti di S. Francesco, el Potesta d’Empoli, el Doganiere, el Camarlingo e molti nobili cittadini fiorentini. E Consoli del comune e popolo di S. Andrea. La compagnia di S. Andrea. La compagnia dei Vergognosi. La compagnia della Madonna,La compagnia della Croce. La compagnia della Numptiata.
« Ebbe 100 doppieri, 30 della Repubblica 20 da Pietro suo figliuolo, 10 da’ Consoli e 8 da ogni compagnia, dieci cavalli, otto coperti di bandiere con diverse a armi, cioè due della repubblica, due del popolo, due dei capitani di parte e due di sua famiglia. Gli altri due uno a pennoncello e uno con cimiero, ispada e a sproni. Cinque fanti con essi cavalli vestiti di mantello uno di scarlatto, co’ vai grossi uno d’azzurro, con frange di vermiglio, uno di pavonazzo foderato di vaio bruno e due di verde con frange d’oro. Andò vestito di velluto vermiglio in letto di sciamito rosso con drappelloni d’oro e otto fanti d’intorno vestiti a nero. Gran a danaro fu dato ai poveri per l’anima sua. Ebbe tutte a le campane a doppio e fu compianto da ogni gente per uomo d’ogni bontà. Era d’anni 27. Fece el Sermone alla sepoltura Corso di Lodovico Adimari. Cantò la messa M. Bindo pievano . . . . Non fu visto ai nostri tempi un mortorio più sontuoso. Cinquecento fiorini fu la spesa: trecento ne pagò la repubblica. »
La famiglia Sandonnini d’Empoli nel 1736 a richiesta di Gio. Gastone granduca di Toscana fu investita da Rinaldo I duca di Modena, della contea da Carniana e Poiano per commuta della contea di S. Donnino e fu ammessa alla cittadinanza nobile di Modena e di Reggio. La medesima famiglia si estinse nella persona del più volte citato Giachino Sandonnini, il quale mori nell’anno 1784 ai 15 maggio.
GIOVAN FRANCESCO FERRANTI autore della Ninfa regina e d’altre poesie.
GIOVAN MARIA SCAPPINI poeta filosofo, giureconsulto, morto fiscale di Pistoia.
GIOVANNI CANI, canonico d’Empoli, che al campione beneficiale del nostro Capitolo è detto M. Girolamo di Leonardo Celli, dottor di legge, provvisto del canonicato dal vicario del proposto Sebastiano Tani nel 1561. Fu vicario generale del vescovo di Volterra Guido Serguidi l’anno 1588.
GIOVANNI D’ANDREA MALEPA GIACHINI pievano d’Empoli l’anno 1467, vicario generale dell’Arcivescovo di Firenze nel 1469, istitutore d’una libreria di mss. pubblica nella sua patria, la quale si dissipò in tempo di peste. Fu detto piovano nell’anno 1470 autorizzato dal Vicario generale dell’arcivescovo fiorentino Giovanni Diotisalvi a compilare le nuove costituzioni del nostro Capitolo, che sono tuttora in vigore, nelle quali vien nominato dal detto Vicario « Virum juris pontificii professorem doctissimum. » Di lui accennò alcune cose il Manni nel sigillo II del tomo XIII. Sebbene dalle scritture del nostro Capitolo non si trovi il prelodato Giovanni col cognome de’ Giachini, pure nonostante è cosa certa, ch’egli apparteneva a detta famiglia, di cui in Empoli ve ne furono due case, discendenti dallo stesso stipite, ed aventi lo stesso stemma d’un becco con tre lune. La famiglia Giachini d’Empoli trasse origine da quello del becco, che fu infra le famiglie antiche, nobili, grandi e potenti fiorentini, ch’ebbe le sue case palagi e ospizi entro le mura del primo cerchio nel popolo di S. Andrea nel Sesto di porta S. Pancrazio di Firenze, come si rileva da due decreti del Magistrato supremo di detta città, uno dei 27 aprile 1604, l’altro dei 22 maggio 1607 riferiti nelle più volte citate annotazioni all’iscrizione sepolcrale del cavaliere Sandonnini, nelle note del gius dei cherici infermi dato alle stampe nel 1741.
Dal soprallodato canonico Giachino Sandonnini si dice a carte 29 che la precitata famiglia Giachini « Si rifugio in Empoli allorché fu cacciata di Firenze cogli altri Ghibellini descritti nel libro del chiodo, che si conserva nella Cancelleria dei signori capitani della parte a guelfa di Firenze, dove tra gli altri sbanditi del Sesto di porta S. Pancrazio e del popolo di S. Andrea si leggono i figli d’Iacopo di Giachino il vecchio. » Alla medesima famiglia appartenne senza dubbio il sepolcro posto presso la porta del Duomo di Firenze detta del campanile ove nello zoccolo del destro stipite d’essa porta si legge:
S. FILIO. S. GIACHOPI
GIACHINI. ET. SVOR.
Nelle note della « Firenze antica e moderna illustrata » tomo 11 a carte 119 ove si riporta la detta iscrizione, si dice che la famiglia de’ Giachini trovasi descritta nel 1311 fra i ribelli del Comune nel Sesto di S. Pancrazio e si citano le « delizie degli eruditi toscani tomo XI pag. 170. » Può essere che tale epoca si riferisca all’espulsione d’un altro ramo della stessa famiglia.
CAVALIER GIOVANNI ANDREA FALAGIANI, che produsse con le stampe un saggio di poesie toscane e nel 1475 libri tre in versi sopra i colori. Fu commissario di Barga, accademico fiorentino, arcade, ec.
GIOVANNI RONCONCELLI che nel 1522 fu arcidiacono di Santona in Francia e proposto della nostra chiesa nell’anno 1545. Di lui parla il Manni riportando il suo sigillo nel tomo XIII in cui ci dà anco la serie dei pievani, poi proposti della medesima chiesa.
GIOVAN VINCENZO TOZZI canonico d’Empoli e lettore ordinario di filosofia nell’università di Pisa, il quale
morì li 9 gennaio 1678.
GIULIANO DI BATTISTA MUGNAINI canonico d’Empoli e dottor di legge. Mori di anni 35 essendo al Governo
della città di Nepi nell’anno 1608 e fu in detta città onorevolissimamente sepolto.
IPPOLITO NERI autore del poema intitolato Il Samminiato e di altre rime stampate. Fu Pastore di Roma morì nel 1709.
IPPOLITO SESOLDI carmelitano dottor di sacra teologia, del quale a lungo ne parla il Cerracchini ne’ fasti teologali. Questo fu progenerale del suo ordine nel 1641. Si vede il suo busto in marmo con iscrizione nell’ingresso del chiostro del convento di Corniola. Morì l’anno 1665.
LEONARDO GIACHINI prima lettore di medicina in Pisa, dipoi archiatro e consigliere del Re di Francia. Pubblicò molte sue opere mediche, meritando le lodi, che a Lui danno il Cardano, Guido Baldo e molti altri. Avvi un’opera che ha per titolo a « Leonardi Jachini Emporiensis Pisis in celeber. acad. medicinae olim. summa cum lande ordinarii professoris in q. librum Rosis arabis medici ad Almansorem regem de partium morbis eruditissima commentaria » stampato in Lione nel 1758. Vedasi più sotto.
LORENZO BONSIGNORI arciprete d’Empoli l’anno 1549. Fu vicario del vescovo di Fiesole monsignor Martelli nel medesimo anno e vicario generale dell’Arcivescovo di Firenze nel 1588, come si ha dal nostro campione beneficiale a carte 34.
LORENZO NERI lettore prima di logica, poi di medicina nell’università di Pisa nel 1643 quindi di logica nell’università di Padova nell’anno 1648 morì l’anno 1677.
LORENZO ORSACCHI Agostiniano autore delle storie di sua religione, di cui fu per più anni procuratore generale. Di lui parla Cerracchini ne fasti teologali. Esisté il suo ritratto in marmo con onorifica iscrizione nella chiesa degli Agostiniani di questa Terra, morì nel 1633. Vedasi più sotto.
LUIGI ZUCCHERINI dottore, filosofo e medico, accademico fiorentino, che diede alla luce la vita di S. Mamante martire. Fu ancora accademico delle Cene.
MICHELE BONSIGNORI, che cantò la recuperazione di Gerusalemme in ottava rima.
MICHELE DURAZZINI agostiniano autore di varie letterarie fatiche. Di lui parla il Gandolfo nel libro intitolato « Dissertatio historica de ducenlis celeberrimis augustinianis scriptoribus » con tali espressioni «Michael Durazzinus de Emporio etruscus S. theologia professor vir in habendis sermonibus ad populum maxime copiosus, et plurimum utilis. » Fu maestro nell’università de’ teologi fiorentini, da cui fu fatto decano nel 1484. Di lui si ha alle stampe «Opus praedicabile editum per theologiae professorem magistrum Michaelem Durazzinum de Emporio augustinianum » in cui sono sermoni per le domeniche dell’Avvento e di Quaresima e per varie solennità della Madonna e de’ Santi. Come può vedersi nel prelodato Cerracchini. Vedasi più sotto.
MICHELE BARDI da Empoli si trova in S. Domenico d’ Arrigo Mucini all’archivio generale di Firenze sotto di 24 settembre 1422 scritto in questi termini « Magister Michael Bardi de Empoli frater S. Spiritus de Florentia. » Vi è stato chi ha creduto, che questo Michele Bardi fosse l’istesso, che il suddetto Michele Durazzini: ma e dalla diversità de’ cognomi e dalla distanza delle epoche par chiare che siano due soggetti differenti.
OTTAVIO MESSERINI cappellano della nostra Collegiata autore di varie poesie in stil bernesco, alcune delle
quali sono riportate nelle « veglie piacevoli » del Manni ultimamente stampate. Quest’Ottavio può esser l’istesso, che quell’Antonio Messerini descritto di sopra, detto Antonio per isbaglio. Fuuno degli accademici delle Cene mori nell’anno 1704.
PIER LORENZO ORSACCHI lettore di filosofia nell’università di Pisa.
PIER DOMENICO BARTOLONI autore delle istorie de’ Duchi e de’ Re di Boemia in tomi IV, di alcune opere mediche e poetiche e ultimamente del Bacco in Boemia ditirambo graziosissimo.
PIETRO SANDONNINI dottor di legge, protonotario apostolico, vicario generale del vescovo di Teste, poi del vescovo di Pistoia Alessandro del Caccia, morì nel 1626 fu sepolto con iscrizione nell’insigne Collegiata, di cui era stato proposto fino dall’anno 1625.
PULIDORO PULIDORI, che oltre aver lasciate le istorie de’ suoi tempi inedite, lasciò anche diversi altri trattati mattematici esistenti presso la nobil famiglia Tempesti di Empoli.
TOMMASO DI FILIPPO PANCETTI giureconsulto assai dotto, morto fiscale di Pistoia.
TOMMASO FERONI canonico d’Empoli e cameriere extra muro: di papa Alessandro VII. morto in Empoli l’anno 1678.
VOGLINO DI GIOVANNI DA EMPOLI, cherico cubiculario del cardinal Pietro Corsini, il quale fece una certa fatica sullo specchio istoriale di Vincenzio Bellovacense scrivendo un libro di excerpti, che cosi è intitolato « Incipit libellus de divisione terrarum, et diversitate gentium extractus de speculo historiali per me Voglinum Ioannis de Empoli clericum florentinae diaeceseos, et cubicularium reverendissimi in Christo patris domini Petri de Corsinis de Florentia, portuensis et santae Rufinae episcopi, sanctae romanae ecelesiae cardinalis, et inceptus in Avinione anno Domini MCCCLXXXII indictione V te die sabati XI mensis octobris pontificatus sanctissimi in Christo patris, et domini mei domini Clementis divina providentia papae septimi. » Il celebre dottor Giovanni Lami nella parte prima dell’Hodoeporicon lo reputa uomo letterato e ne parla altresì nelle note alla cronica di Leone Urbevetano.
VINCENZIO DI VINCENZIO, o come dice il nostro campione beneficiale, di Giuseppe BARTOLONI canonico d’Empoli nel 1634 protonotario apostolico, che fu già proposto di Poggibonsi e canonico di Colle, canonista eccellente morto nel 1635.
Si aggiungono altri soggetti degni di memoria tralasciati dal Manni, perché ne parla a lungo il Cerracchini ne’ più volte citati fasti teologali e sono:
NICCOLO DA EMPOLI sacerdote secolare, che all’archivio generale sotto dì 2 febbraio 1473 vien detto « magister in sacra pagina » perché fu dottor teologo fiorentino, essendo stato incorporato nell’università nel 1465 a leggere e glossare il Maestro delle sentenze. Fu corista della metropolitana di Firenze nel 1475, rettore della chiesa di S. Piero in Gattolino di detta Città e priore della cura di S. Maria a Cortenuova, che ottenne per breve di S. Antonino Arcivescovo nel 1455 ove morì nell’anno 1476.
ROCCO DA EMPOLI agostiniano dottor teologo fiorentino, letter filosofo in Bologna.
STEFANO DA EMPOLI agostiniano dottor teologo fiorentino, predicatore generale in Roma, ed ivi anche lettore.
SIMONE DA EMPOLI agostiniano dottor teologo fiorentino lettore di morale in Pavia.
SILVIO RICCI di Empoli agostiniano lettor di sacre lettere in Bologna, dottor teologo fiorentino.
SIMONI PONTANARI d’Empoli agostiniano dottor teologo fiorentino, lettore di dommatica in Pisa.
I quali cinque maestri si trovano così descritti sotto i loro ritratti nella libreria de’ padri agostiniani di questo convento d’Empoli, come dice il Cerracchini nell’opera di sopra citata.
DIONISIO DI LOTTO LOTTI da Empoli, come asserisce l’autore del nostro campione beneficiale e non da Samminiato, o da Fucecchio, come han scritto alcuni. Fu cappellano della nostra Collegiata nel 1624, e priore di s. Ambrogio di Firenze, ed anche esaminatore sinodale. Nel 1627 fu incorporato nell’università de’ teologi fiorentini, di cui godè del decanato nel 1638. Morì nel 1648 coll’onore esser chiamato da tutti l’oracolo e la quiete delle coscienze, non tanto per la bontà della vita, quanto per la profondità nella teologia, specialmente nelle cose morali.
ANTONIO DI LOTTO LOTTI da Empoli canonico della nostra Collegiata nel 1458 e di quella di S. Lorenzo di Firenze. Fu dottor teologo fiorentino e decano dell’università l’anno 1480. Il medesimo è stato originario di Montespertoli, ma il nostro campione beneficiale lo dice empolese, rilevandosi dal medesimo, che la famiglia Lotti era di questo Paese. Morì nel 1499.
DON FLAVIO CEI, o come altri vogliono ALCEI da Empoli uomo dottissimo, che giusta il Loccatelli nella sua vita fece rifiorire nella sua congregazione Valombrosana gli studi. Fu questi il primo generale di’ detta congregazione, che nel 1550 prescelse per ordinaria residenza del generale la Badia di Ripoli, secondo ciò, che scrive il Moreni nella descrizione de’ contorni di Firenze parte V a carte 222: morì nell’anno 1552. Accennarsi debbono ancora col Manni tomo XV sigillo X varii altri cospicui personaggi e sono:
GIOVANNI DI LUDOVICO DA EMPOLI viaggiatore illustre, la descrizione de’ cui viaggi si legge nel codice F. S. della Stroziana.
GIOVANNI DA EMPOLI compagno d’Amerigo Vespucci ne’ suoi viaggi, si cita dal Migliorucci nelle sue orazioni tomo primo a carte 22 dell’edizione fiorentina del 1747.
E dal Ramusio volume primo edizione del 1563 si nomina un Giovanni da Empoli di cui si ha la descrizione dell’lsola dell’Ascensione scoperta nel 1501, visitata per la seconda volta da Alfonso Alburquerque mentre andava nell’lndie nell’anno 1503, in compagnia di cui fu il nostro Giovanni. ( Può vedersi l’abate Fontanini nel catalogo della libreria imperiale e i viaggi di Giacomo Cook tomo 39 edizione di Firenze nel 1797 a carte 62. ) Di questo Giovanni, che dicesi figlio di Giovanni di Niccolò da Empoli cittadino fiorentino e che morì in Persia, ne scrisse la vita Girolamo da Empoli nell’anno 1530. Vi è chi crede, che questi tre Giovanni siano un solo, o almeno due, secondo che diversamente ne parlano diversi autori.
IACOPO DELL’EMPOLI o da Empoli eccellente pittore, di cui esistono alcune opere nelle chiese di questo Paese, oltre un bellissimo quadro, che si conserva nella chiesa, o compagnia di S. Maria a Ripa nel quale si legge « lacopo di Chimenti da Empoli di Firenze » 1569.
ANDREA BONISTALLI detto il Fracassa, architetto assai noto, di cui si hanno in Empoli vari maestosi edilizi. Vedasi a carte 117.
ANDREA PUCCI, che dal Romagnoli ne’ suoi ricordi mss. si asserisce inventore di lavoro a bulino in bronzo. Un grado di altare di bronzo a bulino contenente molti piccoli santi intagliato dal detto Andrea fu trasferito nel 1533 nello spedale di s. Iacopo e s. Eusebio presso il Ponte a Rifredi, in cui scorrettamente inciso si legge « Fecit hoc opus in civitatis Florentiae Andreas Pucci d’Empoli aurifex » come accenna il Manni nel tomo XIII a carte 113.
Nell’armi si segnalarono:
CANTINO DI DOMENICO CANTINI il quale nel 1397 discacciò da Samminiato il famoso Mangiadori, che con la sua gente tentava di ribellare la Terra dalla repubblica fiorentina, come si disse a suo luogo.
FRANCESCO FERRUCCI da Bernardo Segni appellato empolese di patria, valorosissimo capitano, come dall’lstorie dell’Ammirato e del Varchi. Questo fu proposto, che si dipingesse nella real galleria del granduca di Toscana come illustre nel valor militare.
MARCO DA EMPOLI fu gran capitano sotto Pietro Strozzi. Fin qui il Manni e gli altri autori già citati, che nelle loro opere stampate hanno parlato degli uomini illustri della nostra Terra. Ora poi anderò qui notando un altra mano di uomini a mio credere degni di ricordanza, che ho raccolti da alcune notizie mss. del più volte citato dottor Bartolommeo Romagnoli e tali sono secondo l’ordine ivi ritrovato:
FRANCESCO BUCARELLI fiorentino, ma nato in Empoli il dì 21 maggio 1686 perché il padre suo lacopo era in tal tempo qui potestà per S. A. R. come apparisce dal libro de’ battezzati esistente nell’archivio dell’Opera. Fu il detto Francesco sacerdote della compagnia di Gesù, ed essendo in missione fu martirizzato nel Tonchino dai gentili nell’anno 1724.
ALESSANDRO BRUGIOTTI da Empoli dottor di legge, compose più opere, fra le quali il voto cattolico in Roma nell’anno 1665.
BASTIANO MORELLONE sacerdote letterato d’Empoli, fu maestro di lettere di Lodovico Cardi detto il Cigoli pittore assai celebre.
FRA GIOVANNI DA EMPOLI carmelitano dottor teologo, fu provinciale dell’ordine molto rinomato morì nel 1529.
DONNA FIAMMETTA di Silvestro di Buto di Bianco da Empoli lasciò tutti i suoi beni al monastero di S. Clemente di Firenze per testamento di ser Tommaso da Samminiato rogato il dì 2 giugno 1545 come consta dal padre Richa tomo V delle chiese fiorentine a carte 257.
MESSER PACE DI SANDRO DA EMPOLI fu spedalingo dello spedale di S. Bonifazio nel 1452; e nel 1458 fu spedalingo degl’Innocenti, come si ha dal Richa a carte 314 del tomo precitato e dal Manni tomo XV a carte 154 e nel 1463 fu nostro canonico, rilevandosi ciò dal campione beneficiale, sebbene non lo noti il Romagnoli ne’ suoi ricordi. Mori nel 1478.
CAVALIERE ZEFFI nominato MATTEO DA EMPOLI, compose lo spoglio generale delle commende di S. Stefano P. M. come dal Richa tomo XI parte II a carte 279.
DON BASILIO RIGHI certosino, fu priore della Certosa di Pisa, poi di Firenze e fu anche visitatore. Cosi dalle lettere di Adriano Vandenebro a carte 97. Viveva tuttora nel 1677 come apparisce da un’iscrizione in pietra nel campanile di S. Giovanni Battista in Greti, altrimenti della pieve di s. Ansano.
FRA ANDREA ORSACCHI fratello del padre maestro Lorenzo di sopra nominato, fu provinciale degli agostiniani, ed elemosiniere di madama Cristina di Lorena granduchessa di Toscana.
LORENZO MARTINI poeta da Empoli e nominato dal Migliorucci nelle sue orazioni tomo I a carte 77.
MAESTRO ANTONIO FALAGIANI d’Empoli frate de’ conventuali di s. Francesco fu reggente in Cesena appellato nel libro intitolato « Triumphus seraphicus collegii s. Bonaventurae de Urbe a carte 50: Vir prudens acutissimi ingenti. » Morì circa l’anno 1600; e nel medesimo libro a carte 80 si trova Maestro Francesco Falagiani del medesimo ordine, dottor reggente in Genova, Firenze, Bologna, visitator generale degli studi, provinciale di Toscana o dottor teologo nell’università di Pisa. Morì nel convento di Samminiato l’anno 1625 con esemplarità di religione e di vita.
GIOV. CARLO del Cav. PIETRO PAOLO FALAGIANI dottor d’ambe le leggi, nostro canonico dipoi proposto nel 1746. Uomo di molta pietà e dottrina. Diede alle stampe la Pratica divota in onore di Maria santissima e una Novena in ossequio della medesima – Il precetto d’amare Iddio e la Divozione pratica ai ss. Angioli Custodi. Morì nel 1776.
GIUSEPPE PISTOLESI d’Empoli dottor teologo fiorentino fu piovano di Capraia, poi proposto d’Orsammichele di Firenze, quindi priore de’ ss. Apostoli, esaminator sinodale e uno dei componenti la congregazione degli ordinandi e del seminario di detta città. Morì nel 1754.
FRA ANGELO FILIPPO DI GIULIANO PISTOLESI domenicano de’Gavotti, fu vicario generale della sua congregazione. E fu pure vicario generale della medesima nel 1759.
FRA MICHELE ARCANGIOLO SCARDIGLI d’Empoli.
FRA DAMASO BARGELLINI detto da Empoli sebbene nato in un villaggio prossimo alle Terra,minore osservante di s. Francesco, fu letterato giubbilato, Discreto di questo convento di S. Maria a Ripa, teologo di S.M.I. e provinciale dell’Ordine in Toscana. Compose un libro pe’ suoi religiosi relativo alle interrogazioni pelli ordini sacri. Questo degno soggetto è rammentato dal padre Giov. Lorenzo Berti agostiniano nel suo breviario della storia ecclesiastica come uno fra gli uomini cospicui nell’erudizione sacra del secolo XVIII.
FRA CANDIDO ATTILIO BARGELLINI detto da Empoli, come sopra, minore osservante di san Francesco, lettor giubbilato, passò per tutti i gradi del suo istituto a provincialato di Toscana. Diede alla luce sette lettere contenenti l’esame sull’osservazioni critiche del dottor Anastasio Cammilli alle istituzioni filosofiche del padre Francesco Iacquier. Morì nel convento di S. Maria a Ripa l’anno 1806.
NICCOLO DI FRANCESCO FROSINI da Empoli fu governatore della Rocca di Bibbiena deputato tale il dì 11 ottobre 1498.
PAOLO D’UBALDO FERONI sergente maggiore delle milizie toscane e governatore in Pitigliano e Sorano, dipoi castellano di Pistoia. Morì in Empoli sua patria l’anno 1694 e fu sepolto nel sepolcro gentilizio di detta famiglia esistente nella nostra Collegiata, su di cui fino dal 1654 vi era stato fatto ricollocare un nuovo marmo con iscrizione da Francesco d’Ubaldo Feroni ammiraglio della flotta olandese, come leggeasi nell’iscrizione medesima. La famiglia Feroni era nobilissima fiorentina, fu oriunda empolese, nascendo dal citato Francesco, che acquistò il marchesato di Bellavista. Dell’istessa famiglia fu Giuseppe Maria Feroni arcivescovo di Damaso, eletto cardinal prete dal Sommo Pontefice Benedetto XIV il dì 26 novembre 1753.
FRANCESCO BERNI canonico fiorentino poeta originale in stil faceto, morto nel 1536 fu figlio di Niccolò. Il celebre canonico Salvini in trattar di lui nelle vite inedite de’ canonici fiorentini, parla a lungo de’ suoi ascendenti, mostrando che furon nativi di Empoli e che di qui ne andarono a Firenze.
La famiglia de PAOLSANTI, che fondò e dotò il monastero di monache eretto nel 1642 sotto il titolo di S. Maria del Gesù e la Collegiata di S. Casciano, era oriunda d’Empoli; e per questo ai canonicati della medesima, in mancanza de’ cherici di detto luogo, chiama i cherici empolesi. Fin qui i ricordi manoscritti del Romagnoli. Si aggiungono ora altre notizie relative ad alcuni soggetti descritti di sopra, ritrovate posteriormente.
DOMENICO da Empoli, che è stato detto fondatore del monastero di monache al Borgo s. Lorenzo, dal Brocchi nella descrizione del Mugello è nominato Damiano Manti da Emila. Credesi dunque, che possa essere sbaglio il riferito dal Manni.
ENEA DI CINO GALLETTI secondo l’iscrizione sepolcrale, che esisteva nella nostra Collegiata riportata dal suddetto Manni a carte 128 del tomo XV e secondo ciò che dice il campione beneficiale del Capitolo, fu dottor di legge, eccellente filosofo e poeta eroico latino e toscano. Diede alla luce un poema in versi latini, che descrive le cose più rilevanti dal principio del mondo fino alla morte di Carlo V imperatore dedicati a Antonio Pellicini medico empolese già citato; un altro poema intitolato – Il Gesù – e un altro intitolato – Il Gundebano – e molte altre opere compose, che restarono inedite. Stampò di più sopra le questioni peripatetiche e sopra l’ idee. Morì nel 1598.
LEONARDO GIACHINI oltre l’opere citate a suo luogo scrisse nell’anno 1527 una lettera apologetica in lode del Popone diretta a M. Filippo Valori come costa dal tomo XVIII de’ sigilli del Manni a carte 29 e 31. Il detto Giachini fu uno de’ componenti la società de’ quattro medici i più dotti di Firenze, che verso l’anno 1530 solea adunarsi periodicamente in una stanza di una celebre spezieria situata in un luogo corrispondente alle carceri nuove dette le stinche: l’oggetto della di cui adunanza fu di portare al suo maggiore avanzamento la medicina pratica e raccogliere notizie conducenti a tale oggetto. Gli eruditi professori della medesima società, che furono, oltre il prelodato Giachini, l’Anastasi, lacopo Mini e Pier Francesco Paoli si dichiararono specialmente contro quella setta di medici chiamati arabisti, i quali leggendo alterati nelle traduzioni provenienti dagli arabi i testi d’Ippocrate, di Galeno e degli altri greci maestri depravavano con dottrine erronee la pratica dell’arte esculapia. Dalla surriferita società uscì alla luce una raccolta assai stimata di opuscoli per mezzo de’ torchi di Venezia del 1533; e gli annali oltramontani l’hanno rammentato con sommo decoro. Si ebbe questa notizia dalla Gazzetta toscana dell’anno 1780 numero 30.
Il padre LORENZO ORSACCHI fu qualificatore della generale ed universale inquisizione di Roma, esaminator de’ vescovi e due volte procurator generale dell’Ordine agostiniano; e come dice il Cerracchini ne’ fasti teologali, non gli sarebbe mancata l’onorevol carica di generale, essendo già stato eletto tale canonicamente dal Capitolo, se il cardinal Pallotta protettore dell’Ordine non ne avesse nominato un altro soggetto. Oltre la storia della sua religione, come si disse a suo luogo, diede alla luce anche il Bollario della medesima.
Il padre maestro MICHELE DURAZZINI trovasi negli atti di ser Francesco di Pietro di Neri nell’anno 1481 17 novembre esser detto « Pater magister Michael olim Durazzini de Empulo sacrae theologiae magister ordinis eremitarum S. Augustini conventus S. Stephani de Empulo synodicus et procurator ejusdem conventus. »
Non son finalmente da tralasciarsi que’ soggetti, che a’ giorni nostri si son distinti onorando la Patria coi loro meriti e dottrina. E tali sono i chiarissimi signori
FRANCESCO DEL VIVO giuresconsulto e dottor teologo fiorentino priore di s. Ambrogio di Firenze, consultore arcivescovile ed esaminator sinodale. Nel 1799 fu uno degli ostaggi fatti in Firenze dai francesi nella prima lor invasione della Toscana, coi quali condotto in Francia vi dimorò per mesi 15 (a). Lodovico l re d’Etruria l’onorò della Croce de’ cappellani cavalieri di s. Stefano P. e M. e lo elesse per suo confessore, con cui perciò nel 1802 andò in Spagna. Morì il dì 17 maggio 1817 e fu sepolto in un chiostro presso la chiesa di s. Ambrogio di cui era parroco, ove si legge in marmo I’appresso iscrizione:
FRANCISCO. JOSEPHI. FELIC. DEL. VIVO.
DOMO. EMPOLIA. LOCO. HONESTO.
JURISCONSULTO. ET. CURIONI.
AD. HOC. DIVI. AMBROSII. TEMPLUM.
A. F. C. INCONTRIO. A. MARTINO. P. F. MORALIO.
FLORENTINIS. PONTIFICIBUS.
SIBI. DOCTRINA. PIETATE. DEVINCTIS.
IN. CONSULTORUM. CONCILIUM. ET. DUODECEMVIROS
SACRIS. INITIATIS. PROBANDIS. COOPTATO.
COLLEGIO. RERUM. DIVINARUM. DOCTORUM. FLORENTIÆ.
NEC. NON. COLUMBARIÆ. SOCIETATI. ADSCRIPTO.
OBSINI. TEMPORUM. ACERBITATE. GALLIA. PERAGRATA.
HISPANIA. VERO. SACRIS. EXPIATORIIS. IN. AULA. PRÆPOSITO.
A. LUDOVICO. HISP. INF. HETRURIÆ. REGE.
E. VITA. EXI. XVI. KAL. JUN. ANNI. MDCCCXVII. ÆT. SUÆ. LXX.
CAJETANUS. DEL. VIVO. JOSEPHUS. PAGANICUS. TEST. CURATORES.
MARIANUS. NEPOS. EX. FRATRE. HÆRES. PP.
(a) Un altro di tali ostaggi fu il padre Lorenzo Ricci nostro paesano frate agostiniano, che abitava in tal tempo nel convento di s. Martino di Siena in qualità di curato della parrocchia annessa al medesimo convento. Questo descrisse in tante lettere inedite il « giornale istorico di tutto quello che accadde agli ostaggi toscani nel loro arresto, deportazione in Francia e loro ritorno alla patria. » Morì in Empoli nell’anno 1816 .
Monsignor GIOVANNI MARCHETTI arcivescovo d’Ancira, si è già citato assieme coi due vescovi Giachini nella nota all’anno 1400. Alla qual’ epoca si pone la morte di fra Matteo da Empoli vescovo colocense, poi arcivescovo di Corinto. Vedasi a pag. 116.
Monsignor SERAFINO VIVIANI nato in Roma, cameriere d’onore di S. S. il sommo Pontefice Pio VII, canonico di S. Maria in via lata e assai noto per la traduzione del libro: «Testimonianze delle chiese di Francia sopra la così detta costituzione civile del clero – Roma 1791 per Giovanni Zempel » cominciando dal tomo III perché i primi due furon tradotti dal nostro concittadino Marchetti; si pone fra gli uomini illustri di questa Terra, perché la sua famiglia è originaria di questo luogo, essendo perfino nato in Empoli Domenico Viviani avo del suddetto prelato, come costa dal libro dei battezzati esistenti nell’archivio dell’Opera di nostra chiesa. MICHELE MARIA DEL BIANCO Di questo valente uomo, le cui lodi si son sempre sentite ripetere da quanti lo conobbero, riproduciamo per intiero la necrologia, tanto più volentieri, quanto più dai nostri compaesani sentiamo presentemente rimpiangerne la perdita irreparabile. Il canonico Lazzeri compilatore di queste notizie storiche, si limitò a noverarlo cogli altri illustri Empolesi, non potendo di Lui vivente portare quel giudizio imparziale quale ad istorico conviensi. L’elogio maggiore che di Lui si possa fare è che fu carissimo ai suoi inferiori, i quali in Esso ravvisarono un illuminato fratello ed amico, e non un ignorante superiore degno più di compassione che di disprezzo. Augurando al nostro Paese Proposti che lo rassomiglino in scienza e virtù, diamo principio alla
NECROLOGIA
Empoli 9 gennaio.
« Il nostro dolore per la perdita del reverendissimo MICHELE DEL BIANCO proposto della insigne Collegiata
di questa Terra cerca d’alleviarsi nel dar pubblica onoranza alla memoria di lui.
Egli nacque da Giuseppe Del Bianco e da Teresa Bruni in Empoli l’anno 1752. La famiglia empolese del genitore, e quella fiorentina della madre (ambe cittadine) gli dettero fortuna di onesti natali, e di onorati costumi. Vesti ben presto l’abito ecclesiastico. Apprese per tre anni pietà e lettere nel seminario fiorentino. Nella pisana università dette opera alle filosofiche e sacre discipline, al diritto civile e canonico. Riportò nella Terra natale la purità di costumi, e non il solo titolo, ma pur anco le qualità di dottore. Quindi in Firenze ebbe a maestro nella pratica delle leggi lo zio materno avvocato Attilio M. Bruni, lume del Foro toscano. Fu degno discepolo di tanto maestro, che amò sempre e tenne in gran conto nel nipote I’animo soavissimo e la dottrina. E per quello, e per questa non tardò il giovane Michele ad aver in ricompensa il posto di canonico nella Collegiata d’Empoli, la dignità sacerdotale, l’affetto e la stima di monsignore Gaetano Incontri, che gli affidò lo incarico di istruire i chierici in teologia. Così cominciò il nostro sacerdote a
giovare altrui con i precetti e gli esempi: e quind’innanzi reputò sempre primo dovere del suo ministero sacro l’esser utile cittadino. Migliorò gl’interessi del Capitolo: tenne le veci di canonico teologo dichiarando nella chiesa Collegiata la scrittura santa; insegnò gratuitamente filosofia. « Intanto veniva richiesto per la cattedra di Jus pontificio in una università dell’Italia superiore: quando I’arcivescovo fiorentino Antonio Martini lo prepose alla chiesa e Capitolo empolese nell’anno 1792. Giunto a sì alto grado, da lui non trasse onore, ma lui onorò con i suoi meriti. Fu vero paroco; istituì con la voce e con le opere il suo popolo nella purità dello Evangelio: predicò la carità, segui la carità, tutto intese a fare eseguire la pienezza della legge, la carità. E ad essa si attenne fermamente nello accendersi dei partiti, volti gli animi a nuove cose, sul cadere del secolo.” Non cuoprì passioni ree sotto zelo di religione, private cause sotto pubblica causa: non
predicò dissenzioni, ma concordia; non divise, riunì gli animi: non accese, sedò tumulti e unito ai più ragguardevoli concittadini per la salvezza del suo popolo e della sua patria espose a pericolo estremo la vita. « Pel bene pubblico ogni di più si adoperava. Del suo ai poveri non era largo, ma prodigo. Dotto senza invidia e orgoglio: assueto a studi gravissimi, coltivò pure gli ameni, e con le lettere la poesia la musica sollevò sempre I’animo gentile creato, come al buono, al bello. Nel conversare festevole, schietto di cuore e di labbro, a tutti affabile, a tutti fu caro. Amico a’ buoni, non brigò mai le amicizie de’ grandi: quelle donategli conservò senza tasto, usò solo in vantaggio altrui. – Mostrò come si possa sotto qualunque governo vivere ottimo cristiano ed ottimo suddito: e lo mostrò a tutto il mondo nell’anno 1811. Fermo nella obbedienza alla ecclesiastica disciplina, obbedì senza lamenti e senza insulti alla secolare potestà.
Lasciò gli amici, la patria, la famiglia senz’avvilimento di dolore, e senza ostentazione di fermezza. Fu deportato in Corsica: ivi per tre anni fu dai compagni amato, amato e dirò venerato dagli estranei. – Composta in pace I’Europa, si rimpatriò nell’anno 1814. Siccome partì non tenendosi ingiuriato, così tornò scevro di rancore. Non fece pompa delle sofferte avversità: non credé nulla aver fatto al di sopra del proprio dovere: quindi non ambì premi, pago del premio della innocenza, il sentirsi puro. – Amorosamente si riposò nel suo popolo come un padre tra i figli. Riassunse l’esercizio del suo ministero con l’antico zelo, l’antica carità. Consacrato all’altare fin dalla puerizia, presso I’altare chiuse la sua lunga vita cadente. Appena celebrati tutti i riti solenni nel giorno della natività di Cristo signor nostro In percosso da gravissimo colpo di apoplessia. Confortato dagli estremi aiuti della religione con la letizia del giusto passò di questa all’altra vita nel giorno terzo dell’anno 1825. La sua morte fu per tutti luttuosa: non senza lacrime dell’ottimo arcivescovo Pier Francesco Morali.
« Altri distesamente narrerà le opere dell’uomo raro, che la morte ne ha rapito; ma che pur sempre avrà il nostro amore. »
Fu sepolto nella cappella di S. Andrea nella nostra insigne Collegiata, colla seguente, modesta troppo se vuolsi, epigrafe:
A X Ω
A MICHELE DEL BIANCO EMPOLESE
IL CAPITOLO DELLA CHIESA
ALLA QUALE FU XXXIII ANNI PROPOSTO
POSE QUESTA MEMORIA
COME A SINGOLARE ED AMATISSIMO ESEMPIO
DELLE VIRTU’
CHE POSSONO IN SACERDOTE DESIDERARSI
MDCCCXXV.
GIUSEPPE ROMAGNOLI Cav. dell’ordine di S. Giuseppe, dottor d’ambe le leggi e tra i teologi fiorentini, nostro canonico fino all’anno 1814 dipoi canonico della metropolitana, lettore di gius civile e canonico nel seminario fiorentino, ed esaminator sinodale, e finalmente vicario generale e capitolare della diogesi fiesolana, morto il 7 febbraio 1850.
Dottor VINCENZO CHIARUGI primo infermiere dello spedale di Bonifazio di Firenze, medico di gran credito, elettore dell’università di Pisa assai noto per le opere, che della sua professione ha date alla luce, le quali furon tradotte in Germania (a). Nel 1817 dal granduca Ferdinando III fu fatto presidente a tutti gli spedali eretti provvisoriamente per gl’infetti dal tifo: e nel febbraio 1818 dal medesimo sovrano fu nominato al posto onorifico di soprantendente allo spedale di S. Maria Nuova della città di Firenze.
(a)Trattandosi di persone illustri del Paese è qui da notarsi, come nel mese di settembre 1814 i rappresentanti la nostra Comunità avendo creata una deputazione a fine di felicitare a nome della medesima S. A. I. e R. Ferdinando III dopo il di lui ritorno al trono della Toscana e umiliare ad osso il proprio vassallaggio, furono scelti a comporre la detta deputazione gl’infrascritti soggetti ragguardevoli per la loro dottrina e per gl’impieghi onorifici che ricoprirono, e tali furono i signori proposto Del Bianco e dottor Chiarugi prelodati, avvocato Pietro Lami auditor della Rota Criminale, accademico fiorentino e poeta arcade, avvocato Antonio Bonelli auditor della Rota Civile, avvocato Gaetano Romagnoli auditore del Magistrato supremo Tribunale di Giustizia, e dottor Luigi Busoni gonfaloniere della Comunità. Tutti della comunità di Empoli, e quasi tutti di famiglie precisamente empolesi.
(61) Poiché i detti scudi 600 non furon bastanti al mantenimento del medesimo spedale di cui si tratta, gli furon perciò riunite le doti ricadute, o per morte delle fanciulle, o per aver esse oltrepassati gli anni 33 senza accasarsi. A dì 24 marzo 1795 morì Agostino Cecchi mercante e possidente empolese, il quale per testamento lasciò tutti i suoi beni stabili al suddetto spedale, consistendo il fondo de’ medesimi nella somma di circa ottomila scudi. Onerò per altro lo spedale ai passare un mezzo giulio in aumento d’elemosina a ciascun de due sacerdoti capitolari, che vi celebrano la S. Messa in tutte le feste dell’anno.
(62)
AD ETERNA MEMORIA
CHE LO SPEDALE
PER ORDINE DELL’IMPERATORE
FRANCESCO I GRANDUCA DI TOSCANA
FU COSTRUITO
D’UNA PARTE DEL PATRIMONIO
LASCIATO PER TESTAMENTO AGLI EMPOLESI
DA GIUSEPPE DEL PAPA ARCHIATRO MEDICEO
NEL 1765 Q. M. P.
(63) Questo popolo si nominava anticamente S. Ponziano in Pratignone – e poi – Ponzano – e si disse S. Pio in Ponzano a Ponzano – dacché il proposto d’Empoli Sebastiano Zucchetti per comodo del medesimo popolo che è unito alla cura di detta Terra, nell’anno 1700 vi fece fabbricare una nuova chiesa sotto il titolo di S. Pio V sommo pontefice, essendo stata già da gran tempo demolito la chiesa di S. Ponziano.
(64) L’antica magistratura d’Empoli fino alla suddetta riforma del granduca Pietro Leopoldo era composta
di un gonfaloniere, sette consoli, quattro capitani e ventiquattro persone di consiglio. Il gonfaloniere e tre consoli formavano il seggio di dentro la Terra e questi si estraevano da varie borse, in cui soltanto vi erano imborsate le persone più civili e cospicue del Paese. Altri due consoli si estraevano dalla borsa della lega d’Avane che comprendeva cinque popoli, cioè:
1. S. lacopo ad Avane.
2. S. Maria a Ripa.
3. S. Pietro a Riottoli.
4. S. Martino a Vitiana.
5. S. Cristina a Pagnana.
Gli altri due si cavavano dalla borsa detta della lega di Pianezzoli, che anch’essa comprendeva cinque popoli, ed erano:
1. S. Angiolo a Empoli Vecchio
2. S. Michele a Pianezzoli.
3. S. Leonardo a Cerbaiola.
4. S. Giusto a Petroio.
5. SS. Simone e Giuda a Corniola.
Dei quattro capitani, due erano d’Empoli e di famiglie civili come sopra; il terzo della lega d’Avane, il quarto di quella di Pianezzoli. De’ 24 di consiglio 12 erano del popolo dentro la Terra; 6 della lega d’Avane; gli altri 6 della lega di Pianezzoli. I capitani non avevano voto nella magistratura, ma solo i due d’Empoli intervenivano col gonfaloniere e coi suddetti tre consoli empolesi alle tornate ecclesiastiche. I consoli ab extra e i 24 di consiglio avevano voto soltanto nel consiglio generale. Si eleggevano a sorte altri individui per altri impieghi, che non importa ridire. La tratta di nuovi residenti si faceva ogni anno dal magistrato nel mese di dicembre nella sala della Comunità, a cui doveva assistere il padre priore pro tempore degli Agostiniani di questo Paese, il quale conservava una delle chiavi della cassa ove stavan rinchiuso le borse per la tratta, e detta cassa custodir si doveva nel convento de’ medesimi Agostiniani in vigore degli statuti della Comunità, ciò che fu approvato ancora dal Sovrano nell’accennato motuproprio del 1774; per lo che questo sistema fu osservato fino all’anno 1808 epoca della soppressione del suddetto convento.
Il dì primo dell’anno si portavano in corpo alla nostra Collegiata i consoli vecchi e nuovi sì di dentro, che di fuori la Terra e dopo di avere assistito alla S. Messa, tornati tutti alla solita residenza, si dava il possesso ai nuovi residenti colla consegna delle chiavi al gonfaloniere; e fatto ad essi prestare il giuramento di bene e fedelmente esercitare le loro cariche, con essere stati avvertiti dell’osservanza delle leggi e delli statuti, dopo la distribuzione de’ soliti emolumenti, si licenziava l’adunanza.
La nuova magistratura, che dall’epoca dell’1774 in poi entra in impiego ogni anno il dì 1 di settembre, non usa veruna esteriore formalità di possesso. La sala di residenza pel consiglio della Comunità fu in piazza nel palazzo della potesteria fino all’epoca dell’erezione della medesima in vicariato, la quale essendo stata ceduta pell’udienza del nuovo vicario, il magistrato scelse per le sue adunanze la sala della cancelleria. Il segno per queste adunanze comunitative è stato sempre il suono della campana maggiore della Collegiata, onde il nostro Neri nel suo poema giocoso canta
Suonano gli empolesi la campana
Al gran consiglio, e si conclude poco.
Dopo tal’epoca i rappresentanti la Comunità vestirono un lucco paonazzo, ed il gonfaloniere vestì pure un lucco simile e mutò la sua sciarpa in una tracolla di color rosso e gallonata. l ministri del Monte Pio, che a dette adunanze intervengono col magistrato, hanno sempre usato il lucco nero. Stimo bene accennare in fine, che il cancelliere di questa nostra Comunità fin da tempo immemorabile stende la sua giurisdizione sopra le Comunità della Lastra, di Montelupo e Capraia, di Vinci e Cerreto Guidi.
Queste notizie descritte fin qui si hanno da libri delle deliberazioni e partiti di detta nostra Comunità, che esistono nell’archivio della Cancelleria.
(65) Nelle vicinanze d’Empoli dalla parte di ponente esisteva fino nell’anno 1192 una chiesa in onore di s. Donnino m. Questa fu soppressa nel 1783; e perché non si perdesse la memoria di tal Santo, che è stato sempre in venerazione presso questo popolo, fu decretato che al di Lui culto fosse eretto l’Oratorio del suddetto cimitero.
(66) Il camposanto che attualmente esiste non è sufficiente al bisogno, per esser cresciuta ben molto la popolazione ed aumentato d’assai il numero dei degenti in questo nostro spedale di s. Giuseppe. Sarebbe quindi non solo generoso ma anco provvido consiglio che la confraternita della Misericordia attuasse il pensiero d’un cimitero particolare, come fin dal suo nascere si propose di fare. Però la civiltà dei tempi non permettendo più (come si vede fatto dalle città più colte) di costruire un sepolcreto come quello attualmente esistente, non sappiamo con quanto affetto religioso e patriottico sia stato nella compagnia della Misericordia avversato il progetto cui il clarissimo Magistrato presentò e con quanta prudenza si sia lasciato di accettare le vantaggiosissime condizioni offerte dai rappresentanti il nostro Municipio, quando di buon grado si associava alla Misericordia per costruire un camposanto civico, come la civiltà de’ tempi domanda. L’esigenze d’una nota non permettono che si entri a discutere sulla convenienza d’un bel cimitero, solo aggiungeremo queste parole d’un illustre scrittore:
Sol chi non lascia eredità d’affetti
Poca gioia ha dell’urna . . . . . .
e questo sia per coloro che dopo morte sono indifferenti a lasciare che il loro corpo vada appié d’un ulivo
(forse sarebbe il lor sito), o composto in una sepoltura degna di quella forma che vivente portava in sé i segni della origine divina. (Nota aggiunta)
(67) Il suddetto sacro vessillo del Salvator Crocifisso ogni tant’anni è stato esposto alla pubblica venerazione sull’altar maggiore della nostra collegiata con straordinaria pompa e con apparato decorosissimo, come seguì parlando degli ultimi tempi, nel 1784 nei giorni 24, 25 e 26 agosto. In quest’ultima solennissima festa celebrata sotto gli auspici dell’amatissimo sovrano Pietro Leopoldo, tutto ne escì magnifico e sontuoso, sia per l’armonia di una scelta musica eseguita da’ più bravi professori della Toscana, sia per l’addobbo della chiesa, sia ancora per quello della piazza; la quale formava un ben inteso anfiteatro circondato da archi eguali con terrazzinata al di sopra, il tutto eccellentemente dipinto secondo il disegno del celebre architetto fiorentino Giuseppe Del Moro.
Il concorso dei forestieri (per i quali vi furono soliti popolari divertimenti) fu innumerabile specialmente nel terzo giorno, in cui il Crocifisso fu portato a processione perla Terra. Non mancarono in detti tre giorni le solite compagnie di visitare con offerte la prelodata sacra lmagine, fra le quali si distinse, come altre volle, la compagnia del Crocifisso di Montopoli.
(68) Disse bene in Roma un ufiziale francese nostro paesano: Sapete quali sono vostri tiranni? e accennando alcune casse di danari che dai Francesi si portavan via; Vedete, soggiunse, ecco i vostri tiranni. In fatti da questi nostri novelli padroni l’Italia in più tempi fu spogliata delle sue ricchezze, de’ più preziosi monumenti d’arte si in genere di pittura che di scultura, e d’una quantità di codici antichi manoscritti importantissimi, i quali monumenti le furon poi restituiti per forza nell’anno 1815.
(69) Scrive il Manni nel tomo XV dei sigilli a carte 86 nella nostra piazza si mantenne fino all’anno 1530 un olmo (per lo che la nostra pieve si chiamò anche al mercato all’olmo) e che fu levato per porvi la suddetta colonna col Marzocco. Posto per vero tal fatto, bisogna dire, che vi sia sbaglio nella citazione dell’anno precitato; mentre la base della medesima colonna come si e esposto dì sopra, accennava l’epoca del 1615.
E qui e da notarsi di passaggio col prelodato autore essere stato solito in antico aver le chiese un olmo davanti. Messer Clemente Mazza teologo fiorentino nella vita di san Zanobi data alle stampe nell’anno 1475 al capitolo quarto del trattato secondo, parlando dell’olmo che rinverdì al contatto della cassa di San Zanobi, scrive che l’olmo si piantava avanti le chiese: « secondo l’antico costume, in significazione che le creature senza frutto spirituale meritano di non essere accettate nel grembo di santa chiesa, come al detto albero che non proferisce frutto veruno. »
(70) Non solo in Empoli, ma in moltissimi altri paesi della Toscana seguì nell’istesso giorno tal sommossa di Popolo. Vi fu chi credé che tal sommossa di Popolo fosse stata procurata a bella posta dai medesimi Francesi ossia per scoprir l’animo dei Toscani, ben conoscendo essi non esser generalmente acclamato il loro Governo; sia forse per avere un pretesto di fare quella quantità d’ostaggi; che principalmente da ogni città furon presi subito dopo la detta sommossa. Intanto i proclami, che vennero in seguito emanati per tenere in calma i popoli furon terribili. Si minacciava saccheggiare e incendiare paesi, che si fossero nuovamente sollevati. Le teste de’ nobili e de’ preti si dicevano responsabili, se non si fossero essi opposti al furor popolare. Era in somma una infelicità, e una miseria il vivere in questo tempo di rigenerazione, di libertà ed eguaglianza.
(71) Da quest’epoca fino al ritorno in Toscana del granduca Ferdinando III che seguì nell’anno 1814 tenutosi un tal qual registro delle truppe, che passando di Empoli vi hanno almeno pernottato, si trovano ascendere al numero di circa sessantamila non computato quelle, che di qui hanno transitato soltanto, né quelle che vi hanno alloggiato in scarso numero ( sebbene in certi tempi il passo sia stato quasi continuo) perché di questa non se n’è tenuto riscontro. Ai nostri tempi si è avuto il piacere (altronde per vero scomodo assai) di osservare la diversità di naturali costumi di varie nazioni; perché nello spazio del tempo sopraindicato hanno alloggiato fra noi, e Francesi, e Pollacchi, e Fiamminghi, e Olandesi, e Corsi, e Croati, e Napoletani, e Italiani d’ogni sua contrada, e Inglesi ancora benché in poco numero, in guisa che possiamo darci il vanto d’Ulisse « Qui mores hominum multorum vidi! » (Homer) non già per mezzo di lunghi viaggi come Esso, ma bensì senza muoverci per così dire da casa. L’Ufficialità di dette truppe era ricevuta nelle caso delle persone comode e facoltose del paese dovendosi loro somministrare letto, lume, e fuoco.
(72) Nell’anno 1797 dal nostro Dottor Giovanni Marchetti, al presente Arcivescovo d’Ancira, si produsse colle stampe di Roma un libro intitolato: « De’ prodigi avvenuti in molle sacre immagini specialmente di Maria santissima secondo gli autentici processi compilati in Roma, memorie ecc.» l detti prodigi consisterono per lo più nella apertura e movimento degli occhi, che dal 9 luglio 1796 continuò fino alla metà circa di gennaio 1797.
(73) Sebbene la detta comunità venisse dallo Stato rindennizzata in gran parte delle spese enormi fatte per gli approvvisionamenti di tutte le truppe che nel corso di quindici anni hanno alloggiato in Empoli, con tutto ciò non può negarsi, che non ne abbia risentiti gravissimi danni, la descrizione de’ quali si omette; perché riuscirebbe troppo noiosa. Solo aggiungo, che per evitare, che i soldati semplici alloggiassero nelle case de’ particolari, come molte volte si pretendeva, piuttosto che nelle caserme, nel 1810 dalla nostra municipalità fu posta generalmente una tassa detta degli alloggi più o meno gravosa secondo la possibilità delle famiglie, il di cui resultato distribuito a’ medesimi soldati serviva per quietarli dall’anzidetta prepotenza, e pretensione.
(74) Nel tempo in cui la detta truppa fu in Empoli dal consiglio di guerra furon due sentenziati alla fucilazione. Il primo fu un cotale di condizione benestante della provincia Senese, condotto di là in catene, il quale venne condannato come capo de’ briganti; o fautore di rivoluzione contro il partito repubblicano francese. Il secondo fu un loro soldato, che aveva ammazzato un foriere della truppa. Il primo stando la truppa in arme sul campaccio fu fucilato barbaramente in certo vicolo fra i campi senza che gli fosse manifestata la condanna, e senza e che neppure se l’aspettasse. Al secondo fu letta la sua sentenza, fu accordata la dilazione opportuna con di più gli aiuti spirituali della chiesa, e l’accompagnamento di due sacerdoti del nostro clero fino alla detta piazza del campaccio destinata al di lui supplizio.
(75) Il detto santo è stato sempre in gran devozione presso questo popolo. Nel dì 10 di settembre giorno della di lui festa, il nostro Magistrato comunitativo si porta in forma pubblica alla precitata chiesa degli Agostiniani dopo le ore 10 per assistere alla benedizione del pane, e alla messa solenne; e in questo tempo stanno chiuse le botteghe degli artefici e negozianti del paese. Si dice che tutto ciò si eseguisca in virtù di un voto della Comunità, per avere ottenuta la cessazione d’una pestilenza. Questa pratica è ora andata in disuso, e sono ben 14 anni. (Aggiunta)
(76) Fra tante nuove leggi la più dura, e presso che insoffribile fu quella delle coscrizioni militari. Tutti i giovani dell’età, di anni venti, che estraevano un numero entro il contingente assegnato a ciascuna Comunità, dovevan marciare pella guerra o da se stessi, o per mezzo di un cambio che disastrava col danaro somministratogli una povera famiglia. ln sette coscrizioni, che furon fatte in tempo di quest’ultimo governo francese che durò sette anni incominciati, della nostra Comunità partiron per l’armata compresi pochi cambi circa 150 giovani, dei quali la maggior parte morì nelle battaglie.
(77) Queste Monache rientrarono nel detto monastero il dì 14 dicembre 1814 il quale poi restò approvato fra gli altri pella ripristinazione dalla deputazione de’ tre Arcivescovi della Toscana nel 1816.
(78) Questo convento, previe le debite approvazioni, fu riaperto da’ medesimi religiosi il dì primo agosto 1815.
(79) Anche questo convento venne ripristinato colle opportune facoltà «dai padri Cappuccini il dì 25 settembre 1814.
(80) In tempo dell’assenza del Proposto, anche il clero della nostra Collegiata, e particolarmente otto individui del medesimo per certi falsi rapporti furon presi di mira e dal Vescovo, e dal Governo; e avrebbero sofferta tanto essi, che il capitolo una gravissima disavventura, se un compenso allora creduto plausibile, non ne avesse dileguata la tetra burrasca.
(81) Il dì 12 giugno di questo stesso anno nella sala della Cancelleria in esecuzione degli ordini del Governo dai rappresentanti la nostra Comunità, e da tutti gli impiegati, e notari regi fu prestato solenne giuramento di fedeltà e d’obbedienza al granduca Ferdinando III ponendolo ognuno la mano sul libro de’ santi Evangeli. Tal giuramento fu ricevuto dal Proposto vestito d’abito corale, assistito da due Canonici, essendo ivi presente il Gonfaloniere di detta Comunità come deputato dal medesimo Governo.
Nella suddetta sala si osservava sotto un trono la statua in mezzo busto del prelodato Sovrano. Fu compita questa funzione col suono degli strumenti della banda.
(82) Tal sorte di feste popolari, e con pompa consimile si fecero qui in Empoli in occorrenza di passi di altri sovrani della Toscana, e particolarmente più volte a tempo del re Lodovico l, dell’lnfante suo figlio, e di Maria Luisa di lui madre regina reggente, la quale in simile occasione, esternò il suo gradimento per gli attestati di gioja, rispetto, ed ossequiosa attenzione manifestati in modo speciale da questo popolo per mezzo di lettera del conte Odoardo Salvatico consigliere della maestà sua, diretta a questo Vicario regio sotto dì 23 giugno 1804.
(83) Il medesimo Papa, allorché nell’anno 1809 fu condotto prigioniero in Francia era passato d’Empoli guardato da un ufiziale di gendarmi nella mattina del dì 9 luglio di detto anno. Fu poi talmente occulto il di lui viaggio, che nessuno di questo popolo poté neppure immaginare. Nel dì 22 giugno 1434 passò pure da questo nostro paese il sommo pontefice Eugenio IV andando a Firenze, come rilevasi dal campione beneficiale del Capitolo a carte 19.
(84) Mediante la soppressione degli ordini regolari in Toscana accennata a suo luogo, essendo restati alienati pella massima parte i loro beni, nel suddetto ristabilimento degli ordini regolari convenne diminuire in gran quantità il numero de’ conventi; e perciò volendo il sommo Pontefice, che specialmente le religiose abitanti nel secolo si ritirassero nei monasteri, fu necessario, che come gli altri conventi, così anche questo delle benedettine ne ricevessero un numero assai maggiore del suddetto fissato fin tanto che le monache si riducessero al determinato quantitativo.
(85) L’illustre famiglia de’ Figlinesi d’Empoli discendente dall’antico castello di Figline situato una volta in poca distanza da Montaione pella parte di levante, da cui prese la denominazione o cognome. I signori di detto casato in qualità di conti governavano ab immemorabili il medesimo castello assolutamente, ed indipendentemente da chicchessia. Ma nel 1369 le armi della repubblica incominciando a prevalere sopra di Samminiato, con cui era collegato Figline, la prosapia de’ Figlinesi sull’esempio di altri determinò di cedere il proprio castello a’ Fiorentini, come scrive l’Ammirato, Istoria fiorentine parte I. tomo II, libro XIII, all’anno qui riferito. Per la qual cessione Ugolino, Iacopo, Francesco, Panzino, e Piero Conti di Figline sotto dì 9 settembre dell’istesso anno 1369 ottennero per sé e per loro consorti, e discendenti maschi in infinito a titolo di benemerenza con decreto del Comune di Firenze, per cui furon dichiarati e fatti veri antichi e originarii cittadini fiorentini, come si vede alle riformagioni nel libro di provvisioni dell’anno predetto a carte 81 del qual decreto se ne conserva copia autentica nella suddetta famiglia Figlinesi: onde trovasi nel Manni tomo XVI sigillo IX che tratta di essa famiglia, con documento di persona autorevole, che dice esser « ella inferiore a poche e superiore a molte di quelle, che passano tra le prime famiglie nobili antiche fiorentine». Distratto Figline da’ Fiorentini dopo non molto tempo la famiglia de’ Figlinesi si ritirò in Montaione; ma circa al 1640 venne a stabilirsi a Empoli chiamatavi dal Sovrano di Toscana per presedere all’azienda del sale del regio magazzino, che è in detta terra. E tradizione antica in questa famiglia, che di lei fosse il beato Giovanni da Figline « spiritu prophetiae illustris » giusta una memoria trovata nel convento di s. Francesco di Castelfiorentino, ed ivi sepolto. Per altre notizie di questa stessa famiglia può vedersi il Manni tomo XVI de’ sigilli, sigillo IX suddetto.
(86) Anco nell’anno 1779 il dì 25 aprile giorno di domenica fu esposta, e portata a processione la suddetta sacra immagine per ottenere la bramata pioggia, giacché erano scorsi quattro mesi, dacché le campagne pativano una continua siccità.
(87) Questa Nota non corre.
(88) Le provvisioni per i quattro maestri, e custode delle suddette scuole vengono somministrate dalla cassa comunitativa, dall’eredità del dottor Del Papa, che pagava l’antico maestro, dall’Opera della Collegiata come ereditaria della compagnia di s. Andrea, s. Lorenzo e della santissima Annunziata, che riscuote dallo Stato per i luoghi di monte, che possedeva: qual frutto fu assegnato con rescritto sovrano a vantaggio delle dette scuole.
F l N E delle Note della parte I. della Storia.


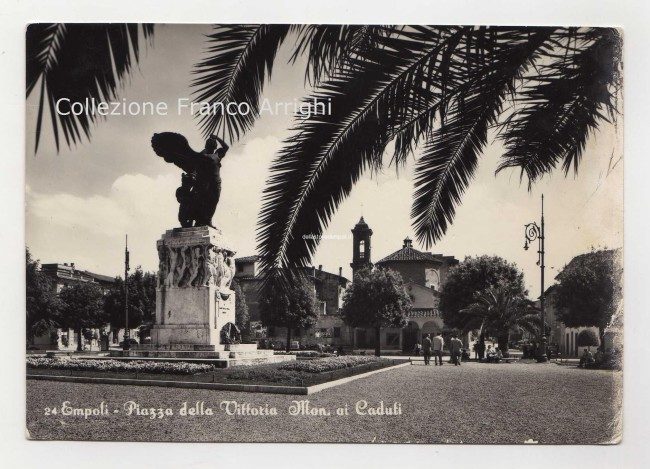
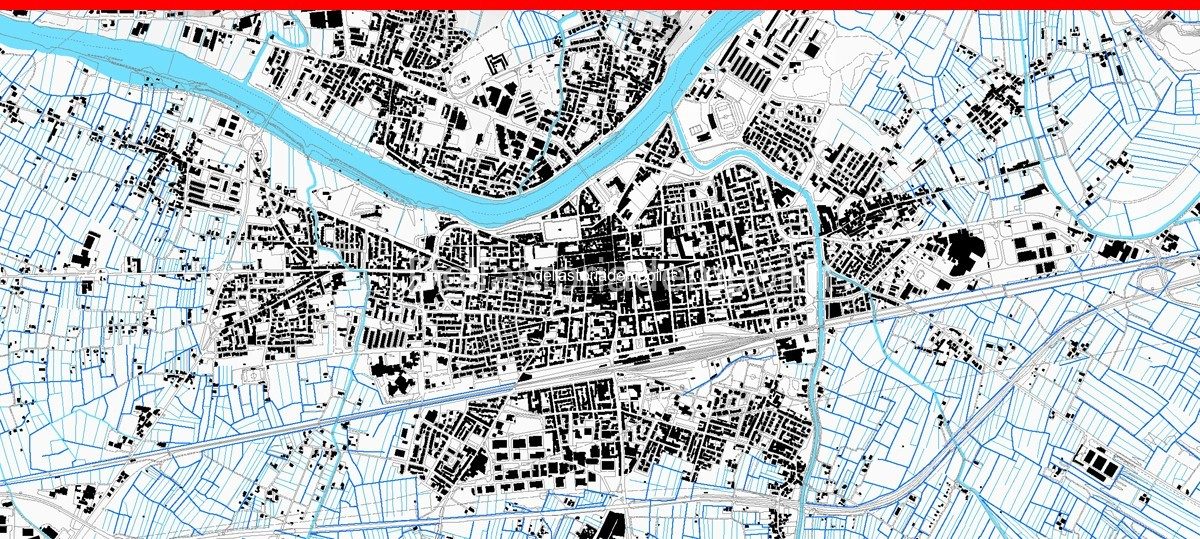
Comments (0)